Il libro su Mikailovka
Nel nostro Cimitero di guerra di Mikailovka.
Ai miei più cari figlioli, i Caduti e Dispersi nella campagna di Russia (1941-1943) ed ai miei carissimi Reduci della Legione “Tagliamento”.
Miei carissimi Reduci, legionari del 63° e del 79° Btg. CC.NN., fanti delle Armi Accompagnamento ed autieri dell’Autocentro, scadono esattamente in questi giorni d’agosto (8, 9, 10) i vent’anni da quando partimmo per la Campagna di Russia, alcuni di noi da Marmirolo, altri da S. Antonio Mantovano, altri da Volta Mantovana.
Noi ci incontreremo tra breve – io spero – per ricordare questa data, da cui ebbe inizio una mirabile storia di martirio e, possiamo affermarlo senza iattanza, di gloria. Ci raduneremo mossi da quel sentimento di fraternità che lega indissolubilmente coloro i quali hanno sofferto gomito a gomito tante prove ed affrontato insieme mille volte la morte.
Ci raduneremo soprattutto per ripetere i nomi e richiamarci alla memoria le gesta dei nostri indimenticabili Caduti e Dispersi. E speriamo che tutti sapranno riconoscere il pacifico diritto di ricordare e di pregare. Lasciate che una volta di più il vostro cappellano vi inviti ad un colpo d’ala di coraggio, di serenità e di poesia.
Se mai qualcuno vuole pavidamente ignorare o passare sotto silenzio o, peggio, irridere il sacrificio dei nostri Caduti e Dispersi e nostro, noi siamo abbastanza grandi di spirito per non restarne turbati.
Ho letto in questi giorni che forse ci verrà concesso di riavere ciò che resta delle ossa dei nostri Morti. Noi che fummo sempre cristianamente umani verso i Caduti russi (e verso i feriti ed i prigionieri russi), noi sospiriamo che ci sia concesso di andarle a raccogliere, quelle carissime ossa. Ci andremmo come ad un sacro pellegrinaggio.
Ma per ora ci è consentito di ritornare lassù soltanto col pensiero. Ed io mi propongo appunto, in queste pagine, di ripercorrere con voi le strade d’allora, di soffermarmi ad ogni luogo ove qualcuno dei nostri morì, di entrare – particolarmente – con voi nel nostro Cimitero di Mikailovka e narrare la storia di ogni fossa.
Non troverete, dunque, qui la storia della Legione, che ci attendiamo dal nostro bravo Avenati. Io non ho né la competenza né la documentazione per farla. E non troverete neppure la memoria di tutti i Caduti di Russia. Perché ignoro la sorte, o ne so qualcosa solo per sentito dire, di quanti caddero o rimasero dispersi dal luglio al dicembre 1942, quando io ero ormai rientrato in Patria. Chissà che il dotto Pappalepore o Margini o Cristofoli o Staffuzza o qualche altro, che abbia vissuto tutto il calvario della Legione, non si senta spronato a completare (e correggere) questi miei appunti!
Quel che leggerete, perciò, non sono che le impressioni, a volte sfocate o lacunose od inesatte, di un cappellano che vide ciò che vide, e lo vide dall’umile prospettiva del vostro sangue e dei «nostri» pidocchi. Con tanto affetto, il vostro ex-cappellano militare mons. Guglielmo Biasutti. Udine, 10 agosto 1961.


CAPITOLO I – Dalle Calabrie al fiume Dnieper.
A Crotone. Agli ultimi di novembre del 1940 me n’andavo, un giorno, da Udine a Gorizia in treno. Nello scompartimento dinanzi a me c’era una contadina di circa 50-60 anni, che teneva in braccio un bambinello di poco più che un anno. Il piccolo dormiva; e finché dormì tutto andò tranquillamente. Ma d’un tratto si svegliò; e, come spesso avviene, si mise a piangere.
La nonna s’adoperò dapprima in tutti i modi per quietarlo. Poi, non riuscendovi, quasi per scusarsi del fastidio che ci dava, prese a dire così: «È il figlio di mio figlio, alpino in Albania. Da parecchio tempo non abbiamo notizie di lui e sappiamo che laggiù le cose vanno male. Sono stata ad Udine, da un maresciallo del Distretto nostro amico di casa, per vedere se poteva darmi qualche informazione (la povera gente si arrampica dove può); ma non sapeva nulla neppure lui, e mi ha detto di sperare e di aspettare. Mio Dio, quanta pena per questi nostri figli! Quando sono piccoli, noi mamme siamo sempre in ansia per la loro salute. Ci si alza la notte, perché ci sembra che non respirino bene o perché si sono scoperti… Poi viene una cartolina precetto; e te lo portano via, il tuo figliolo, forse per mandarlo a morire. Pensavo: quando avrò cinquant’anni mi metterò finalmente quieta, a godermi i figli di mio figlio. Ed ora invece mi tocca ricominciare da capo. Mia nuora è pazza per il pensiero del marito. E tocca a me pensare anche al figlio del mio figlio. Poi, fra vent’anni forse, verrà una nuova cartolina precetto e me lo porteranno via anche lui…».
Io rimasi sconvolto da quelle parole. Ed appena rientrato a Udine presi la penna e scrissi al gen. Guzzoni, chiedendogli di essere arruolato e inviato quale cappellano in Albania.
Avevo dato, un anno prima, l’Istituto «Bearzi» per i fanciulli poveri ed abbandonati ai Salesiani. La guerra mi aveva già spopolato in buona parte la «Casa Ozanam» per gli uomini sperduti (uno dei quali morì in Grecia e fu decorato di medaglia d’oro; ed uno rimase disperso in Russia). Ero, dunque, libero. I miei giovani compaesani (di Forgaria del Friuli) eran quasi tutti della «Julia» in Albania. Perché non sarei dovuto andare a condividere le pene di chi più soffriva e più aveva bisogno di conforto? Il gen. Guzzoni, che un tempo era stato in Udine ed aveva più volte beneficato le mie Opere, mi rispose subito, approvando la mia decisione; e, infatti, dopo un certo tempo fui chiamato alla visita e dichiarato abile. Tuttavia la chiamata non arrivava mai. Sembra che sia stata frenata da Qualcuno, per un malinteso (io credo) affetto o riguardo.
Comunque, nel tardo pomeriggio del 21 febbraio 1941 (se non erro) ricevetti un telegramma da mons. Rufino, ispettore generale dei cappellani della milizia, con cui mi si ordinava di partire la notte stessa con la Legione 63a CC.NN. «Tagliamento», allora in partenza per le Calabrie. Mi presentai al Comando, dove, in verità, tra il serio ed il faceto, mi si disse: «Ahimè! E noi speravamo di partire senza prete».
Ottenuti alcuni giorni per prepararmi, raggiunsi la Legione a Crotone il 25 febbraio. Non senza essere passato per Roma, ove mi fece da guida il cappellano militare della «Julia» don Riccardo Travani, già mio scolaro ed ora arciprete della Metropolitana di Udine; e dove mi fu consegnato, al Comando dei cappellani militari, l’altarino da campo. E così, senza istruzioni ed esperienza, fui scaraventato nell’ambiente militare…
Devo confessare che nei primi tempi mi trovai un tantino a disagio. Ma a poco a poco riuscii ad affiatarmi, sia al Comando – particolarmente col comandante Vannata, già segretario del Ministro dei Trasporti – sia coi reparti. In questo fui favorito dal fatto che un battaglione era formato da Friulani – il 63° -, comandato dal l° seniore Ermacora Zuliani, detto «Mache», e dalla Compagnia mitraglieri di Piacenza, gente schietta e buona. L’altro battaglione, il 79°, era stato reclutato in Emilia, parte nella montagna (3a Cp) e parte nella pianura (1a e 2a), ed aveva per comandante il I° seniore Patroncini e dei carissimi ufficiali subalterni, coi quali e coi loro uomini fraternizzai ben presto. Piuttosto amari, per tradizione, con la «tonaca nera», gli Emiliani sono di grande spontaneità di cuore: e finirono per volermi bene quanto quelli della mia gente. Al 79° era incorporata una Compagnia di mitraglieri di Cuneo, comandata dal centurione Gentile, il quale era stato pretore di Latisana (Udine): gente in gamba e di buoni sentimenti religiosi.
Di Crotone ricorderò solamente due cose: l’una, che potei cavarmi la voglia, sentitissima fin da piccolo, di andare a cavallo, con non poco divertimento dei miei soldati, che in qualche occasione mi combinarono anche degli scherzetti per vedermi… capitombolare; l’altra che facemmo una bella Comunione pasquale, a cui partecipò l’80 per cento dei legionari.
Stemmo a Crotone circa un paio di mesi. Un giorno ci mettevano in allarme per partire per l’Africa, un giorno per raggiungere l’Albania. Ma non accadde nulla. Ebbi l’occasione di assistere allora negli estremi istanti, all’ospedale di Crotone, il primo soldato che morì fra le mie braccia: un fante, non del mio reparto, di Lecce.
Nella Calabria Orientale. Fummo quindi trasferiti a Spezzano Albanese, col comando, mentre i reparti si trovavano nella vicina S. Lorenzo. Qui rimase ferito incidentalmente, ma senza gravi conseguenze, il primo nostro milite; mentre a Spezzano avevo la gioia di ammettere al battesimo un altro milite.
Più tardi il Comando venne trasferito a Castrovillari, mentre il 79° fu dislocato in parte a Spezzano Terme ed il 63° Btg. a Cassano Jonio. A Cassano ricordano ancora le belle funzioni mariane del maggio, che facevamo nella Cattedrale, con l’accompagnamento della nostra bella fanfara. Ed a Cassano si ammalò di peritonite il nostro primo caduto, Dri Geminiano da Porpetto (Udine), che morì all’ospedale di Cosenza.

C’è ancora chi ricorda l’increscioso episodio al Caffè alla Stazione di Cosenza, dove alcuni borghesi non tollerarono il sommesso pianto della mamma di Geminiano. Cercai di spiegare e di placarli, dapprima, ma poi mi indignai per quella crudele insofferenza. E mancò poco non succedesse un grave tafferuglio, perché i miei soldati volevano buttare all’aria tutto. Furon calate le saracinesche ed un certo signore tentò di intimorirmi col solito: «Lei non sa chi sono io». Pare fosse un capoccia del fascio locale.
Finalmente ci arrivò l’ordine di trasferirei nella provincia di Mantova: la Legione «Tagliamento» era stata scelta quale formazione di assalto del C.S.I.R., che doveva partire per la Russia.
Destinazione «Russia». Nel frattempo il console Vannata ci aveva lasciati ed era stato sostituito per breve tempo da un altro console. A Marmirolo di Mantova trovammo il nostro comandante Nicchiarelli ed il vicecomandante Formica, che ci avrebbero poi guidato nella Campagna di Russia. Alla preparazione della Legione diede allora il contributo della sua esperienza il già famoso generale Diamanti.
E fu in questo periodo che a me capitò un grosso guaio. La domenica successiva al nostro arrivo a Marmirolo, celebrai la S. Messa in quel paese per il 63° Btg. ed a S. Antonio Mantovano per il 63° Btg. Armi Accompagnamento, comandato dal caro ed eroico col. Di Franco. Nel pomeriggio mi recai a cavallo a Volta Mantovana. A sera, rientrato nella canonica di Marmirolo, fui colto da febbre altissima. Non mi feci mai visitare e tentai di celarla. Pensavo fosse una febbre intestinale; e perciò mi stremai fino all’inverosimile con purghe e con clisteri. Quasi un anno dopo, soltanto, venne accertato che si trattava di febbre malarica, probabilmente presa in Calabria ed esplosa col mutamento di ambiente.
Vi accenno non per ragioni personali, ma perché quelle febbri mi costrinsero a prolungare assenze dal Comando e dai reparti in quel delicato periodo. Ed anche quando mi facevo vedere, come alla rivista passata da Mussolini a Mantova e dal principe Umberto a Marmirolo, ero in condizioni pietose, che mascheravo a fatica. Quella mia assenza non fu, a mio umile parere, senza danno. Se fossi stato presente avrei potuto interpretare e far comprendere l’anima e la poesia della Legione. Invece, e per la legittima preoccupazione, nel comando, della disciplina formale, e per la malaugurata influenza di qualcuno assolutamente incapace di senso poetico e spirituale e del tutto insensibile al valore delle relazioni umane, si venne a formare un clima alquanto amaro, che solo l’eroismo dei legionari di cinque mesi più tardi riuscì a chiarire.
Ricordo che un giorno, tra una sbornia e l’altra dei miei attacchi febbrili, mi recai alla mensa del Comando, nell’osteria «Al sole veccchio» di Marmirolo. Il discorso si svolse ad un certo momento in un determinato modo, tanto ch’io uscii a dire:
– Sono innamorato …
– Ehi, ehi, Cappellano – fece il gen. Diamanti – andate piano con queste confidenze!
– Sono innamorato – continuai – della mia Legione. I nostri ragazzi son buoni e bravi. E sapranno dimostrarlo quando verrà la loro volta. Per questo soffrirei un mondo, se non potessi partire con loro.
Ha ragione il Signore Gesù quando dice che bisogna soprattutto volersi bene. Sempre. Ma specialmente quando l’unione e l’affiatamento sono assolutamente necessari. È addirittura pazzesco andare verso i pericoli e verso la morte, se non si è un cuor solo ed un’anima sola, fusi dall’affetto e dalla fiducia. Ma lasciamo stare le prediche, utili od inutili che siano.
Tenni celate le mie febbri e non fui sottoposto alla prescritta visita di controllo. Alla fine, però, le mie assenze diedero nell’occhio. Ed io debbo ringraziare il capitano medico dotto Bertrandi, che mi fece ricoverare nell’Ospedale civile di Mantova, anziché nel militare. E qui mi sia lecito raccontare qualcosa che mi pare carino.
Le febbri mi avevano ridotto uno straccio; mi avevano, soprattutto, bruciato il sangue. Ed io, che ero sempre stato anemico, ero allora bianco come un lenzuolo. Come rimediare? Mandai il mio attendente, il caro Baulino, a comperarmi una di quelle pomate che usan le signore per farsi il brunito del soggiorno a mare; e mi feci replicati insistenti massaggi, tanto da acquistarmi una gloriosa tintarella.
Ma all’esame del sangue il dott. Dotto mi trovò solo 2.300.000 globuli rossi. «Impossibile! – disse il primario di allora – Lei si è sbagliato. Guardi che cera! Rifaccia l’esame». E l’esame ripetè quel che doveva ripetere.
Il 9 agosto Baulino mi disse che la Legione partiva il giorno dopo. Ed io uscii dall’ospedale. Il buon dott. Dotto mi disse che era una follia. «Ad ogni modo – consigliò – se può mangi fegato, magari crudo». E ne mangiai, poi, ogni volta che si macellava. Lo sanno bene i nostri addetti ai viveri.
Da Marmirolo al Dnieper. Partimmo, dunque, il 10 agosto; i battaglioni ci avevano preceduto l’8 e 9. E mi andò bene o abbastanza bene lungo il viaggio. Ebbi una buona scossa di febbre il 15, quando celebrai in una sosta sui Carpazi. E mi ubriacai di febbre sotto un cespuglio, a Trusesti, in Romania, accanto alla chiesa ortodossa. Ne ebbi poi altri attacchi ad Adshamka, prima del Dnieper; il 15 settembre sul Dnieper; il 12 ottobre a Mavrina presso Pawlograd. Poi mi lasciarono nell’inverno. E mi ripresero nel marzo 1942. Che febbri, amici miei!
Ma perché, allora, partii? Eroismo? Patriottismo? Una o due ragioni molto più semplici: che ormai m’ero attaccato ai miei ragazzi come l’edera al muro; e che non volevo scandalizzarli col ritirarmi da loro nel momento di maggior bisogno. Mi volevano bene: ma chi avrebbe cavato loro di testa che il Cappellano aveva avuto «fifa», se fossi rimasto?
Con una certa sorpresa debbo dire che non vidi nessuno del Comando cappellani; e che nessuno s’interessò del mio male, eccetto il cap. Bertrandi, che comprese e rispettò il mio desiderio di partire. Be’, lasciamo stare coteste malinconie. Ciò, spieghi, però, ai miei ragazzi perché mai io non li vidi più, per oltre un mese. Li rividi il 23 agosto ad un crocevia poco oltre Trusesti.
Avevamo avuto l’ordine di muoverei. E in quel punto, dinanzi alle macchine del Comando, sfilarono gli automezzi dei battaglioni. Al vedermi, i militi mi fecero festa, perché non sapevano neppure se fossi potuto partire. E poiché la cosa non era regolamentare, fui invitato a mettermi in disparte. E poi la lunga marcia di avvicinamento al fronte (chiedo scusa se la grafia dei toponimi che citerò d’ora innanzi non è esatta. Li ho scritti come meglio ho potuto).
Floresti; Bielzi (dove ebbi un interessante colloquio col comandante Nicchiarelli); ed il 24 agosto Pescianka, passaggio del Dniester, Oligopol; il 25 Balta e Krivoe Osero (pioggia); il 26 Koznepol, Perwomaisk, ed altri quaranta chilometri (l’antipatica sera del brodo sui fuochi); il 27 siamo nei pressi di Ladishinka; il 28 ci passano in rivista Mussolini e Hitler lungo la strada verso Uman; il 29, 30 e 31 agosto siamo a Gruskoje Selo, ove per la prima volta ci passa in rivista il gen. Marazzani, comandante della Divisione Celere, con cui poi dividemmo tanti sacrifici.
Qui ci vengono tolti gli automezzi, che serviranno per portare innanzi la Divisione «Torino»; e noi proseguiamo a piedi, attraversando Kirowo ed andando ad attendarci presso Balca. Il 2 settembre, infine, arriviamo ad Adshamka, a piedi; e lì ci fermeremo sino all’8 settembre, quando ci giungerà l’ordine di scendere sulle rive del Dnieper per dare il cambio alla Divisione Celere. Ad Adshamka nulla di singolare; per me il solito febbrone e per qualcuno due famigerate oche! Ah, quella mensa e quell’automezzo della mensa, che bisognava spingere a braccia, quando si impantanava nelle balke…
Piccole, qualche volta molto piccole, vicende della vita. Quella sera «delle oche», sotto un cielo stellatissimo, guardiamo dallo steccato delle scuole, dove ha sede il Comando, le fiamme di guerra sulle anse del Dnieper, laggiù… Ed io penso e parlo, con aperta tristezza, non della morte che aspetta tutti noi, che coglierà certamente alcuni di noi; ma della necessità di comprendereci, di stimarci e di volerci bene. I nostri uomini faranno il loro dovere! Ne sono sicuro. Dovremmo esserne tutti sicuri. È terribile dire ad un uomo: «Vieni a morire con me». O forse: «Va a morire». Ma un uomo può ascoltare anche un così assurdo incitamento, se tu lo stimi e lo ami…
Quando, sei mesi dopo, stavo facendo il Cimitero di Mikailowka, mi sentivo, certamente, il cuore gonfio. Ma confesso che sentivo pure una orgogliosa fierezza perché avevo sempre creduto nella salda, schietta, umile, semplice bontà e bravura dei miei ragazzi. Perché non posso dirli «miei»?
Il Cappellano militare è un poco come una mamma. Come una mamma che porta gelosamente nel cuore le memorie dei suoi figliuoli; e si compiace a ricordarli ed a lodarli di fronte alla gente. Così parlerò io dei «miei» ragazzi. Forse ciò non è molto militare; ma forse sì. Certamente è del tutto giustificabile, sul piano umano.
Tuttavia io oso affermare che l’affetto «materno» non mi farà abbellire la realtà. Non mi sarebbe possibile anche se lo volessi. Poiché la realtà fu tanto bella, che né parole né stile potrebbero farla migliorare. I «miei» ragazzi, infatti, combatterono come eroi e morirono come santi.
CAPITOLO II – Dallo schieramento sul Dnieper ai capisaldi di Natale (9 settembre – 7 dicembre 1941).
Il 9 settembre prendemmo posizione sulla riva destra del fiume Dnieper. E lo stesso giorno, a sera, assistevo per la prima volta un caduto in linea, il cap. art. Dominici Enrico da Tivoli. I battaglioni si schierarono nelle postazioni scavate nella sabbia e tra le giuncaglie ed i boschi, su una estensione di circa dieci chilometri, a sud – verso la città di Dniepropetrowski – il 79°, a nord – verso Petrikovka – il 63°. Il Comando si trovava alla metà dello schieramento, arretrato di poco dal fiume.
Il 10, a mezzogiorno, una granata ci stronca i nostri primi due caduti sul fronte: Scarpini Ugo di Aquileia (Udine) e Casali Igino da Pomponesco (Mantova), orfano di guerra, che stava aspettando la licenza illimitata.

Il giorno dopo, avevo appena finita la cerimonia della sepoltura di questi due cari figliuoli, ed il ten. Pappalepore, medico del 63°, ed io stavamo compilando il relativo processo verbale, che ci giunse notizia del ferimento di altri due militi, un trecento metri più in là. Lasciammo letteralmente cadere la penna sul foglio e ci precipitammo verso il luogo indicato.
I due feriti erano stati ricoverati in uno di quei piccoli sotterranei che si trovano nelle adiacenze delle case russe e servono per mettervi al riparo dal gelo invernale i raccolti agricoli. E lì assistetti ad una di quelle scene che – a raccontarle – non sembrano vere, ma costruite dalla fantasia e dalla retorica. Ma vi assicuro che è vera.
Cantava per non gemere.
Uno dei feriti aveva nome Sbaiz Francesco, che noi amici chiamavamo comunemente «Franz». Ed ecco il racconto della sua passione, come lo scrissi poco dopo, con i particolari ancor vivi nella memoria.
«Sbaiz Francesco non aveva un lamento. Quando lo avvicinai per dirgli una parola di conforto, mi rispose: – Vedete di lui, signor cappellano – ed accennava al compagno -; egli soffre più di me. Uno dei legionari presenti mi chiamò fuori e mi disse: – Signor Cappellano, fate attenzione allo Sbaiz che dev’essere molto grave, perché a volte delira. Infatti si mette di tanto in tanto a cantare…
Ritornato nel buco, mentre il dottore dava le disposizioni per il trasporto al posto di medicazione, m’accoccolai tra i due feriti per rivolgere or all’uno or all’altro una carezza od una parola. Ed ecco, sentii anch’io lo Sbaiz canticchiare. Mi chinai su di lui; aveva gli occhi chiusi ed i denti serrati ed il viso gli si contraeva come per una morsa di spasimo. Tra le labbra violacee usciva una lenta nenia, mentre il corpo aveva a tratti dei brividi o dei sussulti.
Allora capii perché cantasse così. Non delirava, no. Aspettai che si quietasse e poi lo chiamai: -Franz! Aprì subito gli occhi e mi guardò. – Soffri molto? – gli chiesi. – Oh riesco a tener duro, signor Cappellano – rispose -. Non preoccupatevi per me. Confortate Alcide…
Avevo capito bene. Non delirava! Canticchiava così quando il dolore si faceva violento: e allora l’urlo, che gli sarebbe scoppiato dal petto, dominato dalla sua potente volontà, si trasformava in canto. Cantava per non urlare, per non gemere: sfogava il dolore nel canto…
Lo Sbaiz era ferito a tutte due le gambe: aveva però una scheggia anche nell’addome. Pensammo, perciò, di barellare lui per primo. Ma non ci fu possibile. Tanto egli protestò ed insistette affinché ci occupassimo anzitutto del compagno, che dovemmo accontentarlo. La stessa gara, eroica ed affettuosa, di cedere il primo posto all’amico, si ripetè al momento della medicazione, ma stavolta il medico s’impose.
Mentre il dottore gli estraeva le schegge e gli drenava le ferite con spietata saggezza, irrorando la carne viva d’abbondante tintura d’iodio e ficcando la garza fuor per fuori nelle membra lacerate, lo Sbaiz ripetè di quando in quando il suo cantilenare, ma lamento non gli sfuggì. Diceva solo: – Mi dispiace di dovermene andare dalla linea così presto, senza aver fatto nulla.
Poiché era quello soltanto il secondo giorno del nostro schieramento sulla linea del fuoco. Noi gli dicevamo: – Ma tu hai fatto tutto quel che hai potuto fare e che t’è stato comandato. Non angustiarti, dunque. E lui: – È un conforto piuttosto magro. In realtà non ho fatto nulla; e già me ne vado via, mentre voi restate qui a combattere.
Arrivò l’autoambulanza. Mentre lo caricavamo e gli dicevamo addio, egli continuava a dire: – Compagni, mi dispiace di lasciarvi, mi dispiace di lasciarvi.
Non la ferita, ma il distacco dai camerati ed il forzato abbandono del combattimento gli mettevano negli occhi le prime lacrime. All’ospedale da campo quanti l’avvicinarono furono testimoni, per i cinque giorni che sopravisse, della sua meravigliosa forza d’animo e del suo insuperabile attaccamento al reparto. – Come stanno i compagni? Che cosa fa il battaglione? L’avete dura laggiù? Così domandava a quelli dei nostri che poterono visitarlo. E pregava così i medici: – Guaritemi presto! Voglio ritornare al mio battaglione, voglio tornare tra i miei compagni.
E quando le fiamme violente della febbre ebbero bruciato tutto il mondo della coscienza, di sopra gli abissi del delirio un’idea brillava ancora come stella, una voce ancor suonava con un’insistenza tragicamente solenne. – Voglio tornare al battaglione. Lasciatemi tornare al battaglione.
E tentava di sollevarsi dal letto per andarsene in linea, moribondo indomato: a fatica poterono trattenerlo gli infermieri. Solo la morte riuscì a spegnerne la sublime volontà, e ad inchiodarne le membra generose nell’estrema quiete.
Gli altri Caduti sul Dnieper.
Il 13 settembre immolava la sua giovinezza l’autiere Marin Dino, che imporporava del primo sangue il libro storico dei carissimi e valorosi commilitoni dell’Autocentro dell’Esercito, addetti agli automezzi della Legione. La sua macchina era stata colpita da una granata ed era in fiamme. E lui, mentre ammoniva gli altri a tenersi lontani, s’affannava a tentar di mettere in salvo quanto poteva, quando lo scoppio lo squarciò.
Il 17 moriva all’ospedale Fornaciari Mario del 79°, ferito qualche giorno prima. Io non lo potei assistere, perché venne colpito lontano da me ed avviato subito nelle retrovie. Ma so, dalle testimonianze di chi lo vide ferito, in linea, e poi moribondo all’ospedaletto da campo, che morì da bravo.
Nelle prime ore del 24, l’ultimo giorno che restammo sul Dnieper, un colpo di mortaio stroncava il buon Folloni Gino, mentre era in perlustrazione quasi ai bordi del fiume. Ricordo ancora il dolore della vedova quando nel 1943 fui a Reggio Emilia e visitai parecchie famiglie dei Caduti del 79°. Purtroppo “io” ero tornato e “lui” no.
E passarono così i nostri quindici giorni sul Dnieper; sotto il tiro delle artiglierie russe dall’altra sponda e sotto il tiro dei cecchini, particolarmente insidiosi in certe svolte della strada di acciottolato, su cui vegliavano implacabili coi loro fucili a cannocchiale. Ma ecco alcune note di quei giorni, tratte dal diario di un nostro caduto piacentino, morto poi a Woroscilowa.
«14 Settembre – Tutta la notte forte duello di artiglieria. È sufficiente sporgersi perché ti sparino col moschetto o con mortai. Sono venuti a prendere i nomi di volontari per una perlustrazione sull’altra sponda del Dnieper. Io ci vado.
«15 Settembre – … Dal giorno che sono partito non ho ancora mangiato un pasto abbastanza. Ora ci danno mezza razione di tutto a persona. Dicevano che quando eravamo al fronte non ci mancava nulla. Credevo di soffrire di più per il fumare. Ogni tanto guardo le fotografie dei miei cari. Oggi sento una grande nostalgia e un nodo mi sale alla gola…
«16 Settembre – Nulla di nuovo. Pane nero che sembra crusca; tutto bruciato, pasta dentro. Si mangia pomodoro, cetrioli e cipolle senza condirle, con il pane. Companatico niente. Solo un po’ di minestrone.
«18 Settembre – È 9 giorni che non fumo.
«23 Settembre – Finalmente le sigarette … Arrivate notizie dai miei cari.
«24 Settembre – Abbiamo fatto lo spostamento sotto il bombardamento: 4 morti ed 8 feriti, alcuni molto gravi. Attendati fra due colline, si aspetta l’ordine di passare il Dnieper. Ci cannoneggiano sempre. Penso sul serio se andrò ancora a casa. Ne dubito molto…
Per parte mia, quei giorni ebbi due guai. Un attacco di malaria, il 15, che mi colse mentre mi trovavo in visita alla 3a Cp. del 79°. Riuscii a trascinarmi indietro per un qualche centinaio di metri; ma poi dovetti stendermi a terra, nella prateria. Di sopra passavano le granate, ma non avevo tempo di badarci; e sotto a me c’eran mine collegate con sottili fili crinosi, ma me ne accorsi solo quando cessò la febbre. Più doloroso, infine, uno strano ordine: non avrei dovuto recarmi in linea tra i miei soldati. Presi la penna e scrissi al Cappellano Capo, ora mons. Pintonello, arcivescovo castrense, pregandolo di mutarmi di reparto (lo feci ancora, più tardi). Ed intanto continuai a fare il mio piccolo dovere, come prima. Non riuscivo a capire che un cappellano militare dovesse starsene al Comando e non in mezzo ai militi. Ricordavo le parole di un famoso oratore, cappellano militare della guerra del 1915-18, il Padre Bevilacqua, oratoriano. Le avevo sentite da ragazzo, nel 1921. «Dicono: “Abbasso i preti!” Ed hanno ragione: i preti devono sempre stare in basso: col popolo, coi poveri, con chi soffre». Mi erano piaciute, e mi piacciono ancora.
Un giorno, il 22, ebbi veramente paura. Capitò d’improvviso al Comando lo «starosta» o sindaco del villaggio; e mi disse che un chilometro più su un nostro soldato era morto nella colluttazione con una ragazza. Corsi affannato e sconvolto. Ma non era uno dei nostri; era un olandese, incorporato nelle SS germaniche. Grazie a Dio, i nostri soldati non hanno mai commesso violenze o rapine; salvo, ma di rado, la razzia di qualche gallina, che ordinariamente pagavano o con sigarette o con marchi.
Il diario del Caduto, che ho citato più sopra, accenna al sanguinoso episodio, accaduto durante la marcia di spostamento del 25 settembre. Una granata colpì un palo e la rosa mortale delle schegge uccise a grappolo Zuttion Severino e Peresson Antonio, amici inseparabili anche nella morte, Bariviera Luigi e De Ponte Luigi. Nove altri rimasero feriti più o meno gravemente: uno di essi, Pirusel Edoardo, morì poche ore dopo.
Comandava quella squadra il bravo Carlet, che vidi steso ai bordi della pista coi malleoli sanguinanti. Volle che fossero raccolti e curati dapprima tutti i suoi uomini. E quando fu portato anche lui al posto di medicazione, messo su all’aperto in una piega del vallone ad ovest di Diewka Ftoroi, si preoccupava degli altri feriti e li incoraggiava: «Voi mi chiamavate – diceva – ma io non potevo aiutarvi…». Tutti questi Caduti sono rimasti sepolti sulla destra del Dnieper, nelle fosse che scavammo noi o nei cimiteri degli ospedali. Non so se più tardi vennero raccolti nel grande cimitero di Dniepropetrowski.

Dal Dnieper a Pawlograd.
Il 26 settembre, sotto il tiro dell’artiglieria russa, passammo il fiume Dnieper, sul ponte della ferrovia, di cui eran state fatte saltare alcune arcate: nelle fratture bisognava scendere alla passerella, che i nostri bravi pontieri avevan gettato sul pelo dell’acqua. Passato il fiume, ci avviamo verso una linea provvisoria, per dare il cambio alle Schutzstaffeln germaniche del Westland.
C’è lì un boschetto tutto disseminato di postazioni russe, dove le nostre artiglierie hanno fatto un’orrenda strage. In quel luogo il 27 rimangono feriti nove uomini delle AA, tra cui due sottotenenti; ma uno solo in modo grave, il fante Milani Elenio, che ha una gamba fratturata. E nello stesso luogo, nel pomeriggio del 28, il vcsq. De Roia Leonardo da Cordenons, urtando contro un fucile seminteraato, ne provoca la partenza di un colpo, che gli permette solo di gridare «Mamma». Sul grilletto di quel fucile era irrigidito, come scoprimmo, il dito di un soldato russo ucciso. Seppellisco il De Roia a Kapusino di Kamenka, presso un trivio.
Intanto la Legione avanzava a Mogila Dolgaja, dove la mattina del 29, in uno scontro di pattuglia, cade Colautti Giovanni e sono feriti altri due dei nostri. I russi lasciano quattro uomini sul terreno, tra cui un ufficiale, e tre prigionieri.

A sera arriviamo a Novosiolka, dove sosteremo fino al 3 ottobre. Qui dò sepoltura ad un soldato russo: Makarov Ivan Ossipovic da Staniza Kalzazai nella regione di Novosibirski. Molti prigionieri in questi giorni. La Legione ha avuto, fin qui, dodici morti e trentacinque feriti.
Il 3 ottobre ci trasferiamo a Lomonka di Kamenka, dove il giorno dopo, alle quattro del pomeriggio ci passa in rivista il gen. Messe, comandante del C.S.I.R. Il 5 ottobre la Legione viene per così dire smembrata. Avevamo operato sino allora alle dipendenze della Divisione «Torino ». In quel giorno il 63° Btg. entra a far parte di un Nucleo motorizzato di C.d’A. alle dipendenze della Divisione «Pasubio». Il Comando Legione ed il 79° rimasero invece a Lomonka fino all’8. Non potei seguire quindi le vicende del 63° in quei giorni.
Il diario del mitragliere piacentino caduto parla di freddo, fame e fatiche. Ecco, per esempio, la nota dell’ll ottobre: «Di guardia tutta la notte con un vento fortissimo e freddissimo. È una vita che non so se potrò resistere. Non c’è altro che la protezione della Madonna che non mi fa ammalare. Da giorni che non ricevo posta dei miei cari… Abbiamo i russi a 300 metri. Nella notte scontri con pattuglie. Sull’imbrunire vento freddo con neve. Sono in postazione in aperta campagna, in attesa di spostarsi ancora…».
In quei giorni il 63° perdette tre uomini ed ebbe ventidue feriti. Passon Gino venne ucciso il 10 mentre stava portando il rancio. L’11 alcune granate colpirono gli automezzi, incendiandone alcuni. In quell’occasione venne completamente distrutta la fanfara, che i nostri bravi Fritz e Del Bianco avevano sempre curata con tanto amore. Insieme con gli strumenti della fanfara furono colpiti a morte Pisaroni Sincero e Parigi Carlo. Pisaroni, che nella chiesa di Spezzzano Albanese accompagnava all’harmonium il canto delle laudi mariane e dell’inno del legionario e che dovunque s’andasse cercava in primo luogo un pianoforte per riempirsi il cuore di musica. E Parigi, dalla bella voce tenorile, che mi par ancora di sentire, come in quel mattino di giugno, quando – zaino in spalla – salivamo cantando per la strada che da Spezzano porta a Castrovillari.
Nel frattempo la Legione era stata inclusa in una formazione detta Colonna Garelli, dal nome di un colonnello, già comandante di truppe coloniali. Partimmo da Lomonka la mattina dell’8 coi nostri automezzi.
Attraversammo Novomoskowsk ed oltrepassammo Elisavetovka. Un contrordine del C.S.I.R. ci fa mutare orientamento, e ci dirigiamo verso Snamenka, dove giungiamo all’imbrunire. A notte riparrtiamo ed arriviamo a Dimitrievka, dove dobbiamo dare il cambio ad un Btg. tedesco. Nella marcia abbiamo quattro feriti per incidenti, di cui uno piuttosto grave. A mezzanotte precisa, col furiere Uccelli della Ia del 79° arrivo al Btg. tedesco, dove il maggiore Kramer ci regala una bottiglia di vodka, la prima che assaggiai: buona!
Il 9 siamo in postazione, poco lontano da un grande vallo anticarro, che i russi hanno scavato nella piana più in basso. Le artiglierie russe ci irrorano di granate, ma abbiamo solo tre feriti delle AA. Quest’oggi sento per la prima volta una buona parola. La mattina del 10 attacchiamo. Ma i russi s’erano ritirati nella notte ed il vallo è del tutto sguarnito. Un disegno del Beltrame su «La Domenica del Corriere», che illustra quell’azione, ha pregi artistici, ma niente affatto storici. La Legione si conquistò tanta gloria reale da poter dare di frego alle leggende.
Quel giorno entrai solo soletto in Mishiritz, mentre il centurione Mengoli mi contemplava col suo binocolo. Quando la gente seppe che eravamo italiani e non tedeschi, uscì dalle case e ci ricolmò di gentilezze e di doni: pane, latte, uova.
Procedemmo verso Mavrina. Oltrepassato il paese, uscimmo allo scoperto verso una vallata. Sulla nostra destra, presso un ponte, un nucleo russo resisteva ancora. Avanzai nella piana per indurli alla resa. Fu allora che una sventagliata di mitraglia mi fece buttare a terra. E le uova rotolarono fuori dal tascapane. Ma le raccolsi tutte, prima di ritornare sul ciglio, dove la 2a Cp. si era ormai schierata a difesa. E quella sera ci facemmo una bella frittata. Avemmo solo due feriti nella 2a Cp. del 79°.
Alle 5.30 dell’11 attacchiamo verso Pavlograd ed alle 6.45 siamo già alla linea ferroviaria, che era l’obiettivo del nostro reparto. I tedeschi, arrivati dopo, si seccarono. E mentre essi fanno la bella figura entrando nella città, noi veniamo rinviati a Mavrina. Durante l’attacco avemmo cinque feriti, di cui nessuno grave. Bigi Vittorio, ferito alla coscia, si preoccupa per la marmellata, che portava per tutta la squadra. Mengoli è stato bravissimo.
Il 12 ed il 13 restiamo a Mavrina, dove mi sciroppo uno dei miei attacchi febbrili. Nevica. Il 14 entriamo anche noi a Pavlograd, dove resteremo fino al pomeriggio del 16. Qui si riunisce a noi il 63° Btg.
Del soggiorno a Pawlograd amo dimenticare l’unico episodio poco chiaro di «partisans», in cui però i nostri non ebbero che una parte secondaria: attore principale ne fu un russo bianco, che era stato aggregato a noi quale interprete.
Da Pawlograd a Gorlovka.
Dal 16 ottobre all’11 novembre trascorre un periodo grigio senza storia. Soltanto marcia di inseguimento, ora con gli automezzi, ora a piedi. E soltanto freddo e fango, il terribile fango («grias») ucraino, che blocca l’avanzata.
Attraversiamo o sostiamo nelle seguenti località: Nicolaitz di Nicolajewa (17), Vladimirovka (18), Ivanovka (19), Podgoronie (20-27, di dove si fa un’azione a vuoto verso presunte forze russe nella Balka Orekova), Slavianka (28), Sergievka (29-31, dove dormo e mi assidero in una auto assieme col povero Tomasetti), Griscino Villlaggio (1 e 2 novembre), Griscino città o Griscinograd, detta pure Krasnarmiertz (3-5, dove assisto all’apertura di una «molitva hata» o casa della preghiera, fatta da un venerando pope, Drahasinski Procopi Timofeievic), Novoeconomiceski (5), Golitzinova (6-10). Di questo periodo ecco che cosa scrive il mitragliere caduto sul suo diario:
«21 Ottobre – Dormito sotto la tenda. Vento. Siamo fermi a causa del pantano.
«22 Ottobre – Siamo sempre fermi e piove molto forte…
«23 Ottobre – Dormito con l’acqua che passa sotto le reni. Stiamo andando all’attacco di un centro di fuoco. Sarà come Dio vorrà. Spero sempre nella Madonna. Siamo andati tutto il giorno, tra andare e venire, e non abbiamo trovato niente. Molto male ai piedi.
«24 Ottobre – Dormito sul camion. Vento molto freddo. Sono infangato da giorni fino agli occhi. Credo di avere i pidocchi…
«6 Novembre – Sofferto molto freddo… Piove forte.
«7 Novembre – Dormito in terra in una casa. Piove dirottamente.
«9 Novembre – Dormito in casa. Messa al campo. Fatti bollire i panni e le maglie perché ho i pidocchi. Lavato tutto il dopo pranzo. Tempesta di neve.
«10 Novembre – … Cucito tutto il giorno i panni».

Durante quel grigio periodo feci anche una singolare esperienza, che dopo tutto meritava fatta. Vidi di striscio come si formano a volte le proposte per le ricompense al valore. L’11 novembre, alle 5.30 ci muovemmo a piedi. Attraversammo Nitailovka e Merscinki e sostammo a Ismailovka, detta pure Pervomaika. Di qui ripartiamo alle 16 e marciamo a piedi fino a Iutsovo, dove arriviamo alle 19. Diciamo il Rosario. Alle 21.30 ripartiamo con automezzi della Celere. Bisogna accorrere a Gorlovka, per tentare di liberare la Colonna Chiaramonti della «Pasubio», che era rimasta circondata in Nichitovka.
Arriviamo alle prime case di Gorlovka alle 4 del mattino del 12. E di qui, verso le tre del pomeriggio, ci muoviamo a piedi verso la prima linea, alla periferia nord-est della città, per dare il cambio ai bersaglieri del 3° Rgt. Accorro e mi imbatto in alcuni ufficiali, di cui uno è un colonnello. È il colonnello Carretto, che appena mi vede la croce rossa sul petto, mi domanda: – Lei di che reparto è? – Della Legione «Tagliamento», signor colonnello. – Oh, finalmente! – dice – Sia lodato Iddio! – E mi stringe calorosamente la mano.
È quasi sera. Mentre i nostri legionari corrono a prendere quota, io mi precipito verso alcuni bersaglieri feriti; altri bersaglieri arrivano stremati o feriti da un attacco contro il cerchio russo di Nichitovka. Faccio quel che posso per confortarli e dò l’assoluzione ai più gravi.
Poco dopo, nel buio, il col. Carretto è ancora accanto a me. Ma non mi riconosce.
– Chi è lei? – chiede.
– Sono il cappellano della «Tagliamento» – rispondo.
– Ah, grazie, grazie – soggiunge -. Poveri i miei ragazzi!
Lui ed i bersaglieri temevano che il loro attacco non fosse riuscito e che i russi muovessero al contrattacco. Invece il sacrificio non era stato vano. La Colonna Chiaramonti quella notte potè disincagliarsi dalla morsa che l’aveva rinchiusa per più giorni. Una bufera di neve ci diede poco dopo il benvenuto. E lì la Legione restò schierata in linea fino al 27 novembre.
Il 17 morirono, per uno stesso colpo di mortaio, Manghi Giuseppe e Salati Manfredo. Li portai a seppellire all’ingresso di Gorlovka, accanto ad alcuni caduti dell’80° Rgt. Fanteria. Ma poi, mettendo a posto le povere cose che avevo cavato dalle loro tasche, trovai nel portafoglio di Manghi Giuseppe da Villa Gavazza di Reggio Emilia una tessera dell’Associazione giovanile cattolica e la fotografia della sua fidanzata. Sul rovescio di questa era scritto: «Se dovessi morire prego i miei compagni di mettermi questa fotografia sul cuore. Grazie!
Ed io fui triste perché l’avevo ormai sepolto e non potevo esaudire quell’estremo e caro desiderio. Ma quando, alcuni giorni più tardi, altri compagni lo seguirono nel martirio e nella gloria, pensai di raccogliere tutti i caduti della Legione affinché riposassero insieme come insieme avevano combattuto. Perciò esumai il Manghi e fu con viva commozione che deposi sul suo petto la piccola foto ch’egli aveva desiderato di portare con sé oltre la morte. Se non l’avessi potuto fare, quel «grazie» mi sarebbe suonato come un rimprovero; ora invece mi pareva che quell’ottimo figliolo me lo dicesse davvero, piano piano, nel cuore. E, più felice, egli mi pareva rimettersi a dormire un sonno tranquillo.
Il 18 novembre la la Cp. del 79° ebbe l’ordine di saggiare lo schieramento russo dinanzi a Nichitovka. Era il primo pomeriggio. Sereno e sole in cielo, un candido manto di neve in terra. Immaginarsi se non divennero subito facile oggetto del tiro delle mitragliatrici e dei mortai. Il cent. Avenati ed io accorremmo dal Comando. E a poco a poco gli uomini riuscirono a rientrare. Quelli della 3a del 79° si fecero delle belle risate allora, per una certa paletta che, rientrando, mi misi a scudo sulle basse terga. Ma si ha un bel dire: puoi aver fatto prodezze, ma se torni ferito lì, ti dan la baia.
Avemmo quel giorno ventiquattro feriti. Li portai alla più vicina sezione di sanità. Sei vengono messi in una stanza, mentre i due più gravi – due capisquadra – sono portati immediatamente nella vicina sala di operazione.
Uno è Tagliavini Otello di Poviglio in quel di Reggio Emilia. Mi chino su di lui:
– Coraggio, Tagliavini.
Non si lamenta. Pensa certamente alla creatura che ha a casa e sul volto si stende una accorata tristezza. Ma si riprende subito e sussurra:
– Sia fatta la volontà di Dio. Sa di morire.
L’altro è il caposquadra C. Tre pallottole gli hanno perforato il fianco sinistro.
– Abbi fede! – gli dico – Fede in Dio e fede nella guarigione. Se tu credi di guarire, lo spirito aiuterà la carne.
– Sono certo di guarire, signor cappellano – mi risponde -. Ho tre angioletti a casa che pregano per me.
E sorride. È talmente sereno e coraggioso, lì sul tavolo operatorio, che i chirurgi stessi ne sono sorpresi.
Nella stanza vicina si leva un canto. La bella voce tenorile, fresca e vibrata, sgombra di tristezza quelle stanze d’ospedale. Il capitano medico domanda:
– Chi è che canta?
Un infermiere corre a vedere e informa:
– È quella camicia nera che ha il malleolo fratturato.
Dico: – Vedete come sanno soffrire i miei legionari. E se vedeste come sanno combattere!
Ma non erano rientrati tutti; cinque o sei mancavano, e temevamo fossero rimasti, morti o feriti, sul terreno. Quando a sera chiesi dei volontari per andare a ricercarli, bisognò respingerne molti. Andammo Tonolini ed io con sei uomini. Percorremmo tutto il terreno, a ventaglio, fino a sentire le voci dei russi, che parlottavano nelle loro postazioni; ma non trovammo nessuno. Al ritorno, però, sapemmo che erano rientrati tutti, e salvi, da un fosso più ad ovest. Vennero ricuperate però tre salme di bersaglieri ed una di un fante dell’80° Rgt.
Ed infine il 24 novembre un colpo di mortaio colpì nella stessa postazione Pisa Umberto e Bagnoli Vincenzo. Il povero Pisa non ebbe che il tempo di gridare: «Dio, mamma!». Bagnoli sopravvisse poco più di un’ora. Una scheggia gli era penetrata dalla regione lombare destra ed attraversando tutto il bacino era arrivata a fior di pelle sulla coscia sinistra. Un’altra gli era entrata in cavità sotto la scapola destra.
Gli dissi, quando ancor non avevo visto lo scempio delle ferite:
– Coraggio, Bagnoli! Raccomandati con me alla Madonna e poi se guarirai andremo insieme a Castelmonte (località sopra Cividale del Friuli ove è un Santuario).
– No – rispose -. Andremo alla Madonna delle Grazie in Udine; sono uso andare lì.
– Va bene – consentii – andremo lì.
Ma, quando lo spogliai, sul letto operatorio dell’O. da C. 837, e vidi da me e per il cenno dei sanitari che non c’era nulla da sperare, cominciai a prepararlo ad una buona morte!
– Vincenzo – dissi – la ferita è grave, ma tu sei un uomo e non hai paura. Subito i medici ti opereranno. Perciò adesso mettiti nelle mani del Signore…
Fece segno che sì e lo confessai, e gli amministrai l’Olio Santo. Gli diedi da baciare il Crocefisso prima del rito: alla fine fu lui che volle baciarlo ancora con una passione di fede impressionante. E se prima era stato agitato ed irrequieto, ora si mise calmo calmo. Volle solo essere sollevato per mirar si l’addome.
– Mi sento tutto rotto lì – disse. Lo sollevai e vedendo la parte esternamente sana si riadagiò sul tavolo. Di fronte c’era una finestra ch’egli aveva ben veduta dapprima. Ad un tratto allungò il braccio sinistro, mi afferrò violentemente una spalla ed attirandomi su di sé disse con voce angosciata e gli occhi sbarrati:
– Non vedo più, non vedo più!
Lo esortai a star buono ed a rimettere la sua vita nella volontà di Dio.
– Mi sento andare tutto – sussurrò -; mi pare di perdermi…
– Non si perde mai chi va col Signore – dissi -. Ripeti adagio con me: Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l’anima mia!
– Gesù, Giuseppe, Maria – disse – spiri in pace con voi l’anima mia.
E stette buono buono giungendo le mani. Poi a poco a poco sbiancò e morì.
A Gorlovka restammo fino al giorno 28. I primi giorni ci fu un freddo intenso. Il termometro scese a -18°. Noi avemmo 6 congelati. Anch’io m’intorpidii le mani, celebrando il 16 la Messa su una collinetta, dinanzi le postazioni della la Cp. del 63°: mi dolsero le dita una settimana. Vi feci un cimiterietto con 10 Caduti russi, di cui uno ignoto: degli altri ho tutti i dati sul mio diario. E prima di partire raccolsi in un unico luogo anche i nostri cinque Caduti di Gorlovka.
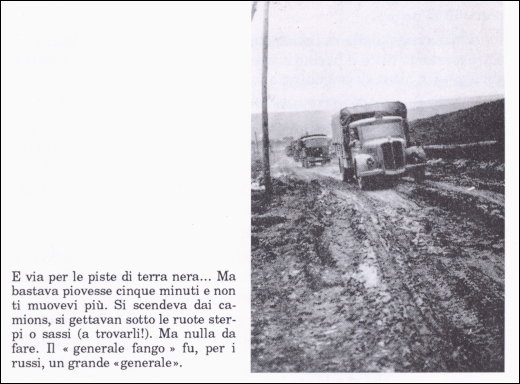
A Shelesnoie Selo.
Il 28 lasciamo Gorlovka ed a mezzogiorno arriviamo a Shelesnoie Selo, su una zona tranquilla dello schieramento del C.S.I.R. Quelli del 79° sono addirittura… a New York, una colonia tedesca con 800 abitanti e 5 fabbriche. Qui non ci sarà molto da fare. Soltanto pattuglie nella terra di nessuno (i russi sono molto lontani), specie lungo le Balche Shelesnoja e Skotovatoja. Il cento Mutti ne fa una coi suoi uomini sino a Nelesnoje. Una matta passeggiata ci facemmo, Cividino ed io, il 30 fino alle prime case di Komsomoletz.
Il l° dicembre vengo a sapere dai lancieri di uno squadrone del Rgt. «Novara», che fanno parte con noi del Gruppo Garelli, che devono uscire di perlustrazione nella terra di nessuno. Sono piuttosto preoccupati, sia per le insidie dei partigiani o soldati russi, sia per il timore della inefficienza dei loro cavalli, provatissimi dal freddo. Per incoraggiarli e per aprirmi la strada a celebrare da loro il 5, primo venerdì del mese, dico che facciano preparare un cavallo anche a me. Il col. Garelli vince alcune resistenze e posso partire. Facemmo quel giorno una curiosa galoppata a Shachta Dvinazettvazet o Rudnik e Komsomoletz. Nel 1949, per il ricordo di quella cavalcata, un ex-ufficiale del «Novara» mi sosterrà validamente in una difficoltà per le mie Opere di carità di Udine.
Il 2 viene un pope a riaprire una casa alla preghiera; è reduce da dieci anni di prigionia in Siberia per la fede. Nel villaggio c’è un altro prete ortodosso, ma che ha aderito al verbo comunista. La gente non lo stima. Parla invece con commozione del vecchio santo parroco, che gli atei hanno talmente tormentato da ridurlo alla pazzia; è morto – mi si dice – di fame e di freddo per la via, senza che nessuno osasse soccorrerlo.
Il 3 dicembre il 63° Btg. parte per il fronte, in una zona lontana da qui, e va a schierarsi con la Divisione Celere. Il 4 celebro la S. Messa ad un gruppo di artiglieria: è la festa della loro patrona S. Barbara. Il 6 partiamo anche noi, alle lO. Passiamo per Jessinovataja e per Stalino ed a notte, sul camion del maggiore Di Franco, comandante le AA., arrivo a Slobodo Orlovo, ove è acquartierato il 20° Btg. del 3° Bersaglieri.
Stiamo per assumere lo schieramento in linea all’ala sinistra della Divisione Celere, mentre alla destra si trovano i bersaglieri del col. Carretto. Sarà su questo nuovo schieramento che la Legione, dal 7 dicembre al 25 gennaio 1942, avrà il suo glorioso bagno di sangue; e sarà di lì che ripartirà nel luglio 1942 per le gloriose gesta dell’agosto sul Don. Fino ad oggi, 6 dicembre, la Legione ha avuto 21 Caduti, 102 feriti (di cui 41 rimasti al reparto) e 8 congelati.
CAPITOLO III – Il Natale di sangue del 1941.
Dal 5 al 18 dicembre.
Il primo a raggiungere il nuovo schieramento fu il 63° Btg., che ci aveva – come ho detto – preceduto di qualche giorno. Esso si attestò il 5 dicembre nel villaggio di Malo Orlovka, che era l’estremo caposaldo a sinistra del settore della Celere. Più a sinistra ancora si stendeva la Divisione «Torino». Poco dopo, la 2a Cp. del 63° andava ad occupare il villaggio di Svecenko Ftoroi, un paio di chilometri sulla destra, sul ciglio di una balca profonda. Sul colle di là della balca, a circa due Km., c’era un altro caposaldo di prima linea, Novaja Orlovka, tenuto da una Cp. del 79° Btg. Alla sua destra c’erano i bersaglieri del 18° Btg., nel villaggio di Ivanovka.
Alle spalle di Malo Orlovka, nel villaggio di Crestovka, il giorno 7 venne a collocarsi il Comando della Legione. Mentre alle spalle di Ivanovka, c’era il villaggio di Mikailowka, con le restanti Compagnie del 79° ed il Gruppo Borghini della 3 a Artiglieria Celere. Proprio il 7 dicembre la la Cp. del 63° compì una ricognizione in forze su Plotski, un borgo circa 3 Km. a nord, di là d’una balca.
Io arrivai a Malo Orlovka ad azione compiuta. Ero partito a piedi da Slobodo e poi ero salito su un automezzo col maggiore Litta, che morirà eroicamente nella famosa carica sul Don, l’agosto del ’42. Avemmo nove feriti, di cui i più erano già al posto di medicazione ed altri stavano arrivando. Ti ricordi, Batel, che «crosta» quando feci per stenderti su un pancone? Quel giorno avevo – caso rarissimo – la borraccia piena di cognac: fu fatta fuori in un baleno.
Purtroppo, in quella circostanza, quattro uomini risultarono dispersi: Urizzi Francesco, il cui cadavere venne trovato mesi dopo, e Piani Carlo, Zanutto Armando e Bragagnini Francesco, di cui non si seppe più nulla.
Verso sera s’offrirono in molti di andarli a ricercare. E ci andammo. Ma ad un certo limite il cent. De Apollonia molto saggiamente ci trattenne. Poi si sparse la voce che la notte qualcuno arrivava dinanzi alle nostre postazioni e parlava in italiano e chiamava per nome – si disse – alcuni dei nostri. Tentammo allora le ricerche una seconda volta, percorrendo tutta la terra di nessuno, ad arco da Malo a Novaia; ma senza risultato.
Sulla notte del 9 una pattuglia russa sbucò da un cespuglione a NE di Malo, nel tentativo di cogliere di sorpresa due nostri uomini che erano di perlustrazione. Ne nacque una zuffa, in cui rimase ucciso Cogoi Arcangelo. Ma i russi dovettero ritirarsi; e chiazze di sangue mostrarono che essi pure avevano avuto dei feriti.
Portai la salma del Cogoi a Crestovka, e lo seppellii accanto a due fanti italiani, che – mi disse la gente del luogo – eran rimasti uccisi in una puntata, parecchi giorni prima del nostro arrivo. Si vedevano ancora le buche delle croci, che – diceva ancora la gente – erano state strappate e bruciate dai russi in un loro breve ritorno offensivo.
In quei giorni ebbi a soffrire non poco. Sia per un procedimento del tutto inammissibile, a mio parere, verso un Caduto. Sia perché desideravo al di sopra di ogni cosa che nella Legione regnasse un perfetto affiatamento. Pensavo di non avere il necessario prestigio per far superare certi atteggiamenti. Avevo sentito dire che da poco era venuto cappellano al 3° Bersaglieri, don Mazzoni, medaglia d’oro della guerra 1915-1918. E scrissi una seconda volta al Cappellano Capo, che mandasse me coi bersaglieri e don Mazzoni con la Legione. Ripeto: solo nell’addolorato desiderio di chiarire certe situazioni.
Ebbi un colloquio, indimenticabile, col cent. Mutti. Ne ebbi altri col Comandante e con qualche ufficiale. Desideravo, soprattutto, che venisse tenuto nel giusto conto quanto facevano e quanto soffrivano i nostri legionari ed i nostri soldati. Per esempio, le rischiose ed assideranti pattuglie notturne. Senza parlare delle continue privazioni o sofferenze quotidiane. Ecco, allora, delle annotazioni tratte dal diario del mitragliere caduto:
«…I pidocchi mi danno un vero martirio… Incontro e sparatoria di pattuglie. Guardia continua di notte… Continua molto freddo… Da qualche giorno arriva molto poco da mangiare. Ho sempre una fame da lupo che non posso descrivere. Giorno che ho in mente molto mia povera mamma. Detto rosario… Bisogna stare molto attenti… Molte ore di servizio… Sempre in posti pericolosi… Il rancio arriva regolare. Ieri sera abbiamo fatto la polenta con la zucca, l’ho mangiata con un po’ di latte. Non fa tanto freddo. Scritto a tutti… Bisogna stare molto attenti… Sono in attesa di posta e sigarette… Bisogna stare molto attenti… Molta attenzione di notte… Sono in attesa della posta… Vorrei scrivere una lettera d’amore alla mia Adelia e i propositi fatti, ma non mi riesce… La mia mente da diversi giorni non fa altro che pensare quello che devo fare quando sono a casa… Ho ricevuto notizia da mio zio che la mia Adelia sta o è stata poco bene. Ho il diavolo addosso di sapere la verità… Oggi nevica con stravento ed è molto freddo come da qualche giorno…».
Sono le note che danno il quadro della piccola sofferta vita del legionario dal 7 al 24 dicembre. Note intense, eppure così pacate! Si sente già nell’aria odor di battaglia vicina. La prima avvisaglia ci viene da Novaja Orlowka, la mattina del 18 dicembre.

L’attacco del 18 contro Novaja Orlowka.
Nebbia densissima. Non vedresti un uomo a venti passi. Il capomanipolo P., solida figura di piemontese, se ne va col caratteristico passo da montanaro ad ispezionare un’arma pesante, posta alla estrema sinistra del schieramento. Ed ecco emergere improvvisamente dalla bruma, a dieci passi da lui, due figure con le mani levate in segno di resa. Sono due soldati russi che vengono a darsi prigionieri, i quali con parole e con cenni fanno capire all’ufficiale come nel boschetto lì presso ci siano altri cinque loro compagni, pure bramosi d’arrendersi. Il capomanipolo, accompagnato dai due russi, va a far preda: si carica dei sette fucili – quattro sulla spalla destra e tre sulla sinistra – e poi s’avvia verso il Comando della Compagnia, lui in testa ed i sette prigionieri dietro in fila indiana e mani in alto.
Mi sono indugiato a narrare questa cattura perché, scrivendo, mi pare di sentirmi accanto il capomanipolo Ezio Barale ed il sottotenente mortaista Girolamo Zangrande, carissimi indimenticabili amici. Furono essi che mi raccontarono la scenetta. Mi diceva Barale:
– Avresti dovuto vedere P.! Sembrava un arsenale ambulante. Se ne veniva avanti, balzelloni più che mai, felicissimo di portare novità. C’era qualcosa di buffo nella scenetta. Poiché li aveva disarmati, sì, del fucile; ma erano ancora armatissimi di bombe e di pugnali.
E Zangrande rincarava:
– Peccato non aver potuto prendere una fotografia! Era una processione fantastica.
Barale e Zangrande, giovani ed allegri, amavano trovare il lato buffo fino sulle soglie di morte. Erano felici di poter sorridere e quando trovavano una briciola di umorismo se la godevano un mondo. La stessa guerra la facevano con cuore sbarazzino ed eroico, come se fosse stata un gioco più grande e più impegnativo.
Sette giorni dopo, cioè nella battaglia del Natale, scomparvero entrambi dopo aver combattuto fino all’ultima cartuccia. Barale lo trovai due mesi più tardi sepolto nella neve. E dello Zangrande seppi soltanto che fu visto fermarsi presso alcuni feriti del suo plotone, nel generoso intendimento di salvarli. I suoi cari ne ricevettero una cartolina nel 1942, tramite la Mezzaluna Rossa. Era stato fatto prigioniero, ma non è ritornato.
I sette prigionieri riferirono che quella mattina era stata fatta, dall’altra parte, una più abbondante distribuzione di vodka, perché la stessa sera i russi ci avrebbero attaccati. Approfittando dell’ubriachezza degli ufficiali e dei compagni essi eran fuggiti ed eran venuti a darsi prigionieri.
Viene la sera. Una sera però tanto accecata dalla nebbia che non può salvare i nostri, seppur vigili, da una certa sorpresa. Qui, in questo capannone al centro dello schieramento, sta una Breda, che da un’ampia breccia aperta nel muro avanza la canna verso il nemico. Sono all’arma i tre uomini di turno: Garofolo, inserviente di sinistra; Inaudi, il tiratore; e Garnieri, inserviente di destra. Il primo è un friulano, gli altri due sono piemontesi.
Garofolo Umberto un’ora fa ha cavato dal portafoglio la fotografia della moglie e l’ha baciata più volte: a casa ha tre creature, una delle quali gli è nata dopo che se n’è venuto in Russia. Stavano conversando per far correre l’ore e qualcuno esprimeva apprezzamenti sulle donne russe, sgraziate e mal vestite. Egli aveva osservato:
– Non c’è donna come la donna italiana. La mia, poi, è la meglio di tutte.
Ed aveva cavato la fotografia per baciarla mentre – in un raccolto silenzio, per la commovente semplicità di quelle parole e di quel gesto – il pensiero di tutti volava alle case, alle spose, ai bimbi.
È Garofolo che scorge per primo, entro la nebbia, il nemico:
– Sono i russi! – dice ad Inaudi.
E Inaudi si precipita sull’arma e preme il bottone di sparo.
Ma contemporaneamente una raffica di mitragliatrice russa risponde: e Garofolo, colpito da un proiettile che gli è penetrato dalla bocca, aperta nel grido d’allarme, s’accascia sul compagno. Dalle labbra gli esce appena qualche estremo respiro che sembra un lamento.
– Che c’è da piangere? – lo rimbrotta quasi Inaudi – Non avrai mica paura? Sta su e passami i caricatori.
Ma Garofolo non piange e non ha paura. Garofolo muore: è morto.
Garnieri passa subito al suo posto e poiché non c’è né tempo né spazio per comporre la salma dell’amico, mentre con una mano sorregge il caduto con l’altra fornisce al tiratore le munizioni. E la Breda canta: e tutto lo schieramento si risveglia, empiendo le tenebre del crepitio e dello scoppio di tutte le armi.
I russi però, fasciati dalla nebbia e dalla notte, sono a pochi metri dalle case. Qui alcuni sono già a ridosso di una di esse; e con le bottiglie incendiarie, piene del cosiddetto «cocktail Molotoff», la mandano in fiamme.
Intanto le artiglierie di Crestowka e di Michailowka cominciano a tuonare, secondo l’indicazione dell’ufficiale pattugliatore:
– Accorciare di cento metri!
– Accorciare di cinquanta!
Il sottotenente Zangrande sta facendo festa coi mortai da 81 e le bombe d’alta capacità. I proiettili fanno la celeste piroetta per precipitare a soli cinquanta metri dalla nostra linea. Ma ecco una bomba a mano, scagliata da un russo che s’era fatto sotto, scoppia contro la mitragliatrice dell’Inaudi, inceppa l’arma, ferisce lui ad una coscia e quasi acceca con la zaffata della fiamma Garnieri, l’inserviente superstite. Mentre Garnieri si getta fuori a bombe a mano contro il nemico, l’Inaudi corre con l’arma in una stanza ove c’è luce, la riaggiusta e la riporta in postazione, ove entrambi continueranno a combattere fino a che il nemico sarà posto in fuga.
Solo allora si presenteranno al luogo di medicazione, non senza aver prima composta la salma del camerata Garofolo che col grido d’allarme aveva a sé procurata la morte ed ai compagni la salvezza.
Il giorno dopo raccogliemmo e seppellimmo i cadaveri nemici. Eran quasi tutti bruciati dalle stesse fiamme che avevano acceso. Solo ad uno trovai il cilindretto di bachelite col rotolino della carta di riconoscimento. Si chiamava Ilgninski Obrognislau Odrauzievic e nel luogo riservato al grado c’era la qualifica di «comandante di tank». Li seppellimmo decorosamente, mettendo un recinto di legno intorno alla fossa e ponendovi sopra una croce di ferro.
Ed io caricai la spoglia di Garofolo su una slitta e scesi a Mikailowka, ove lo seppellii. Fu nel luogo inaugurato dalla sua fossa che formammo poi il nostro Cimitero di Mikailovka.
Ritornato a Novaja, vi anticipai il Natale, celebrando la S. Messa e distribuendo la Comunione a tutti quelli che poterono parteciparvi. Si diedero il cambio nelle postazioni per fare il loro anticipato Natale. Comandava la Compagnia l’ottimo cent. Mengoli. Ed io celebrai nella casetta dove abitava il Cm. Tonolini. Passai ore bellissime con quei cari ragazzi. Non so spiegarmi neppure adesso perché mi venne l’idea di fare il Natale in anticipo proprio a Novaja. Non mi sarei mai immaginato che per la gran parte di loro il Natale sarebbe stato un Natale di morte.
La battaglia del Natale.
La vigilia del Natale, a Crestowka, dove aveva sede il Comando della Legione, ci si mise a fare un po’ di pulizia in uno stanzone buio e pidocchioso, per la Messa di mezzanotte, mentre il cappellano in un angolo attendeva a quell’altra pulizia, confessando. Si preparò un modesto altarino, vennero confezionati sei lumi a nafta con sei scatolette da carne e si scovò persino un «harmonium» per accompagnare con qualche motivo musicale la cerimonia sacra.
I nostri legionari, i nostri fanti mortaisti e cannonieri e gli artiglieri delle batterie aggregate affollarono, nell’ora sacra al mistero di Betlem, l’umile stanza che somigliava molto alla stalla in cui nacque Gesù.
Davanti all’altare, come Saul che di tutta la testa si ergeva sul suo esercito, circondato da tutti gli ufficiali, c’era l’alta figura del Comandante la Legione. La luce fumosa delle sei scatolette schiariva soltanto la bandiera tricolore, messa a fondo dell’altare, e, sul bianco di essa, la Croce ed uno di quei piccoli presepi-cartolina, che s’aprono ad armonica, arrivato dall’Italia con la posta del giorno prima.
Distribuii la S. Comunione a quasi tutti i presenti e rivolsi alla fine del rito alcune parole d’augurio al Comandante ed a tutti i nostri combattenti. La Messa riuscì tanto altamente suggestiva che ne rimanemmo commossi. «È stata la Messa più bella a cui abbia mai assistito in vita mia – mi dissero molti -; meglio che in una cattedrale!».
Noi ci aspettavamo che i russi avrebbero approfittato della notte del Natale, sacra alla nostra fede, per attaccarci. Ed infatti, alle 0,30 del 25 una formazione russa attaccò il caposaldo di Malo Orlowka, ma venne decisamente respinta. Nove prigionieri diranno che, per l’errore di un ufficiale, le truppe destinate alla grande offensiva non s’erano incontrate all’ora prevista, e cioè alla mezzanotte del 24. L’attacco in forze fu quindi rinviato alle prime luci del 25.
M’ero gettato, vestito, sulla brandina da campo, quando alle 6 del 25 le artiglierie di Crestowka cominciarono a tuonare. Seppi che Malo era investita da un furioso assalto. Mi precipitai lassù ed assistetti all’ultima fase del combattimento.
Mentre correvo di postazione in postazione per controllare se ci fossero dei feriti e per dire una parola di fede, i legionari volgendo il capo per vedere chi passasse, mi lanciavano un gioioso «Buon Natale, signor Cappellano» e si riconcentravano subito sulle armi. Il ten. Pregelio, ardito e scanzonato, mi invitava a vedere come tirava con l’alzo a zero sul boschetto Tre Croci, coi suoi cannoni anticarro.
Verso le 9 parve che dinanzi alle postazioni fosse ormai silenzio. Ed io ottenni dal cent. Mutti di uscire a raccogliere i feriti russi rimasti sul terreno. Ma dal boschetto una raffica di mitra mi costrinse a rientrare. Il fuoco riprese e cessò del tutto verso le 10. Il prigioniero Siimeon Sacko dirà: «Ho visto cadere almeno una settantina di miei compagni, tra cui parecchi sottufficiali». Ed altri sei prigionieri dichiareranno che il 50 od il 60 per cento degli attaccanti era stato messo fuori combattimento. Noi a Malo avemmo solo alcuni feriti, di cui l’unico grave il caro Siro Cisilino che morirà giorni dopo all’ospedale da campo 837.
Verso la sera del 25 un russo, rimasto tutto il giorno nella neve, riuscì a trascinarsi presso ad una nostra postazione ed a lanciarvi una bomba a mano che ferì – non gravemente – una delle nostre più vecchie ghirbe, già pratico di guerra. Anche il russo ebbe una gamba spezzata da una raffica di mitragliatore. Mentre il medico gli curava la ferita, io gli mondavo la imboccatura delle maniche, che erano un blocco di ghiaccio, e sfregandogli con la neve le mani congelate, lo rimproveravo dolcemente perché non si fosse arreso prima: «Noi siamo italiani – gli dicevo – e gli italiani sono buoni. Vedi come ti trattiamo». Mi rispose: «Jeslija ransce snal!» (Se l’avessi saputo prima!). E poco dopo, al ten. Pappalepore, che si avvicinava a vedere come stava, diceva con calore: «Tovarish doctor, spassiba!» (Compagno dottore, grazie!).
L’attacco russo del Natale, che investì tutto il settore della Celere, mirava a penetrare a cuneo per la vallata di Alexeievo Orlowo. Bisognava, perciò, scardinare soprattutto i capisaldi di prima linea di Novaja, tenuto dalla 2a Cp. del 79° Btg. con due plotoni di mortaisti e di cannonieri del 63° AA., e di Ivanovka, tenuto dal 18° Btg. del 3° Rgt. Bersaglieri.
A Ivanovka i bersaglieri combatterono a lungo eroicamente, ripiegando poi su Mikailovka. Lasciarono nelle isbe una trentina di feriti, che trovammo tutti uccisi il giorno 28, quando riconquistammo quel caposaldo. Ne benedirò io il Cimitero il 6 gennaio, sotto la neve; ed il col. Carretto chiamerà ad uno ad uno i nomi dei suoi Caduti con la voce rotta dalla commozione.
A Novaja Orlowka noi avevamo meno di 200 uomini, tra camicie nere e soldati delle Armi Accompagnamento. Li comandavano il cent. Mengoli, i Cm. Tonolini, Codeluppi, Monelli e Barale ed i sottoten. Micale e Zangrande. L’attacco cominciò alle 6 del mattino. I russi erano certi che ne avrebbero avuto ragione d’impeto, o con poca fatica. Il ten. russo Michael Ilia Semionovic, che catturammo il 28 a Woroscilova e che mi si affezionò nelle due notti che passammo assieme, confidava: «Sapevamo che a Novaja eravate pochi; ma ci accorgemmo subito che dovevate aver ricevuto rinforzi, perché la resistenza fu assai maggiore di quanto ci aspettassimo e spezzò l’impeto dei nostri, compromettendo tutti i nostri piani». Di rinforzi, invece, non ce n’erano stati affatto.
Circa 900 uomini della 962a Divisione di Fanteria russa irruppero contro il nostro caposaldo e l’avvolsero anche alle spalle. Alle 8 le comunicazioni telefoniche erano già tagliate. Il cent. Mengoli aveva fatto appena a tempo a telefonare: «I russi sono moltissimi. Intensificare il tiro delle artiglierie. Noi ci difenderemo fino all’ultimo».
Poco dopo doveva gettarsi fuori dalla casa, dove aveva sede il Comando, per ricacciare a bombe a mano i russi, che in quel punto riuscivano già ad infiltrarsi. Poi corse, insieme col suo portaordini, ad ordinare lo spostamento di un’arma pesante per tamponare quella falla dello schieramento. Ma nel ritorno rimaneva colpito da una fucilata al petto e cadeva al suolo sui margini della strada.
Il fedele portaordini si chinò subito su di lui per soccorrerlo, ma il centurione gli disse:
«Non preoccupatevi di me. Per me è finita. Corri dal Cm. Tonolini e digli che si assuma il comando. E dì agli ufficiali che resistano fino all’ultimo».
Il portaordini andò a portare l’estrema comunicazione del comandante e poi si mosse per ritornare in suo soccorso. Ma intorno a lui che giaceva ferito al suolo c’era già un nucleo di russi. Allora i nostri, ritirandosi dalle case più avanzate, fecero quadrato verso est una prima ed una seconda volta, e continuarono a contendere il passo al nemico casa per casa. Fu una lotta terribile e tragica.
Quando, verso le 11, essendo esaurite le munizioni venne dato l’ordine di dirigersi verso Mikailowka o Ivanovka, ed i superstiti sotto il tiro dei mortai e delle mitragliatrici russe, nel freddo e nella bufera, iniziarono quella che doveva restare famosa come la «via crucis» del dì di Natale, nell’ultima casa rimase a proteggere il ripiegamento il capomanipolo Tonolini Vittorio con alcuni pochi. Il sottotenente Zangrande Girolamo, intanto, s’affannava a portare in salvo i suoi feriti, e per quel pietoso indugio restava preso nella morsa.
Dalla casetta si scaricavano sul nemico le ultime cartucce. Poi si fece, d’improvviso, un eloquente silenzio. E qui cedo la parola ad una donna russa che affermò d’aver visto la scena di persona:
«Poiché dalla casa degli italiani non tiravano più, un ufficiale sovietico si avanzò da quest’altra verso di essa, attraverso l’orto, e d’albero in albero. Nessuno sparò. Quando fu a pochi passi si aprì la soglia e ne uscì il vostro ufficiale, un giovane alto, senza capello e con le mani aperte, come per dire che non aveva più “patrone” (cartucce). Allora l’ufficiale russo gli si avvicinò, gli battè la destra sulla spalla in segno di ammirazione e, presolo a braccetto, se n’andò via con lui».
Così si chiudeva, col riconoscimento dello stesso nemico, l’eroica resistenza di Novaja Orlowka, di cui la Legione «Tagliamento» si gloriò come di un fatto d’armi sublime, anche se sfortunato.
Quel giovane senza cappello, era il mio carissimo amico c.man. Tonolini, un «mugugnatore» di temperamento, con cui avevo stretto cordialissimi rapporti nelle sabbie del Dnieper. I pochi superstiti di quella eroica avventura narrano di lui:
«Egli era dappertutto; alle mitragliatrici e tra i feriti; dava ordini agli ufficiali, incoraggiava i combattenti, organizzava due volte il quadrato difensivo, faceva innalzare barricate, spostava le squadre secondo il bisogno, scagliava bombe a mano; aveva perduto l’elmetto e correva da un punto all’altro a capo scoperto, calmo, terribile, invulnerabile».
Era suo attendente un vecchio combattente mantovano, di nome Ghiselli, che aveva fatto da ordinanza anche a me, dal 18 al 23, allorché ero stato a Novaja per l’anticipato Natale. Ferito anche lui, nella prima ora di combattimento, sarebbe voluto restare, ma il Tonolini volle che partisse verso Mikailovka; tuttavia prima di lasciarlo lo baciò affettuosamente. Quando più tardi il buon Ghiselli viene a sapere che il suo ufficiale non è rientrato, si leva dalla paglia e dice: «Voglio andar a morire col mio tenente». E brancola verso l’uscita. I camerati accorrono per fermarlo, ma lui è già caduto a terra.
Il Tonolini morì tre anni dopo, in prigionia, nel campo n° 74, colpito a sua volta dal tifo petecchiale, dopo essersi prodigato nell’assistenza dei prigionieri ammalati prima di lui. Così mi raccontò don Carlo Caneva, cappellano della «Julia» e fondatore del Tempio dei Caduti in Russia a Cargnacco. Ed una delle cose più dolci della mia povera vita è la testimonianza di don Caneva, che Tonolini mi ricordò a lui in quel triste luogo con memore, cordiale amicizia.
Due o tre chilometri alle spalle di Ivanowka e di Novaja Orlowwka, nel fondo della valle, c’era – come ho detto – il caposaldo di seconda linea di Mikailowka, dove c’era il resto del 79° Btg. al comando del l° seniore Patroncini, il gruppo d’artiglieria del maggiore Borghini ed il Comando di settore. I russi cominciarono a piovere da tutte le parti: dalla balka tra Scevcenko e Novaja, dalla balka di Ivanovka e dalle balze ad est. Mikailowka doveva essere espugnata ed espugnata subito, perché era la posizione chiave di tutta la valle. Ma non venne presa mai.
Legionari, fanti ed artiglieri – i quali, quando non poterono più usare dei cannoni, si mescolarono agli altri nelle postazioni – formarono una barriera invalicabile. Di quella gloriosa resistenza io ricorderò solamente l’episodio della morte del cent. Mario Gentile, comandante della Compagnia mitraglieri di Cuneo, così come me le raccontò il nostro indimenticabile «Peder» cioè il medico del 79° dott. Pietro Azzolini, trucidato poi a Vetto nel 1945.
Il Gentile era corso a disinceppare personalmente una delle sue mitragliatrici e fu ferito mentre stava orientandone il tiro quasi allo scoperto, per poter meglio arrestare i russi che dilagavano giù dalle quote verso Mikailowka. Appena colpito, non si preoccupa di sé, ma ai suoi mitraglieri che accorrono sgomenti dice:
– State tranquilli, ragazzi, e resistete sempre.
È portato al posto di medicazione. E non ha un lamento. Sorride anzi. Dopo due mesi riesumandone la salma per una migliore sepoltura, ritroverò quel sorriso intatto come se fosse qualcosa d’incorruttibile ed eterno, e mi fermerò stupefatto a contemplarlo. Io non ero presente alla sua morte, poiché mi trovavo a Malo Orlowka. Fu il medico che, con grande senso cristiano, gli suggerì parole di fede. Ed il buon centurione, sollevando lentamente la mano, si fece un ampio segno di croce.
Cinque giorni prima me n’andavo a celebrare la S. Messa in una casa russa, ove erano di stanza alcuni legionari.
– Dove vai, cappellano? – mi chiese.
Gli dissi dove. E lui:
– Aspettami. Vengo anch’io.
Venne infatti. E lì, fra le camicie nere, assistette devotamente a quella che doveva essere la sua ultima Messa.
La ferita era gravissima, tanto che il centurione cadde presto in quello stato di assopimento che poco è più morte. Ma se ne risvegliò due volte.
La prima fu per invocare i suoi due bambini, e fare loro, da tanto lungi, l’ultima più soave esortazione:
– Diddy!… Pucci!… – disse – Buoni!… Buoni!…
E mentre parlava così, muoveva le mani a carezzare, come se fossero lì, come se sentisse al contatto delle dita le due testine care.
La seconda volta, si riscosse per dire: – Mitraglieri…
Poi tacque per sempre. Il medico rievoca quell’istante con queste eloquenti parole: – Mi parve trasfigurato e luminoso come un santo d’altare!
Un racconto a parte meriterebbe l’azione compiuta il giorno del Natale della 2a Cp. del 63°, di stanza nel villaggio di Scevcenko Ftoroi, dedicato alla memoria del grande poeta ucraino. Quella Compagnia era comandata da una delle più tipiche figure della Legione, il cent. De Apollonia, «mugugnatore» ed antiretorico per eccellenza ed insieme di un singolare e freddo senso del dovere. Quel che fece coi suoi uomini è forse un po’ lasciato in ombra, proprio per la sua natura, schiva di esibizionismi. Ma fu, a mio parere, un’azione intelligente ed efficacissima.
Ricevuto l’ordine di accorrere in soccorso della 2a Cp. del 79° a Novaja, il De Apollonia vi si mosse con la sua Compagnia. Ma i russi riempivano la balca tra lui e Novaja. Egli allora andò controllando e disturbando i movimenti russi dall’alto, con una insistenza ed una audacia che costò delle sensibili perdite, anche per il mitragliamento e lo spezzonamento degli aeroplani russi. Infine, con una manovra perfetta arrivò nei pressi di Crestowka e protesse la ritirata del Comando della Legione.
Ma forse il più efficace rapporto di quella azione traspare dal diario del mitragliere caduto, che si trovava appunto con quella Compagnia.
«25 Dicembre – Montato di guardia ore 21,30. Ore 1,30 alla mitraglia. Dormito un po’ vestito. Ore 7 dobbiamo spostarci. Mitragliati e spezzonati due volte. Visto aggiramento 79° Btg.; 200 tra morti, feriti, dispersi, fra i quali Dorini e Gatti. Due Divisioni russe… Nevica e non si può stare riparati causa pericolo di accerchiamento. Seguitato tutto il giorno a fare spostamenti. Legione tutta ritirata. Noi invece ancora al paese (intende a Crestowka), a causa 4 camion. Dobbiamo proteggere ritirata. Siamo un 30 uomini. Venuti i russi fin davanti la mitraglia. Fatto prigioniero allungando la mano. Venuta pattuglia russa. Ripiegamento tutta fretta. Sono tutto sfinito e bagnato. Ho due dita nere… Ore 22: andati di nuovo in postazione. Attaccato».
A Crestowka tutto il presidio del comando – legionari, fanti ed artiglieri – combatterono fino al pomeriggio. Verso le 2 o 3 si ritirarono ordinatamente a nord, nel caposaldo di Malo, rimasto intatto. Ricordo che c’era una nebbia insidiosa. Io uscii da Malo e mi arrampicai su uno dei pali di controllo dei lavori agricoli per vedere se i nostri avevano la via libera. Grazie a Dio, tutto procedette bene. E la sera del Natale il Comando Legione era al riparo nell’indomato caposaldo di Malo Orlowka. In quell’azione morirono Pregnolato Luigi e Ronutti Giovanni e rimase ferito gravemente Mauro Vittorio che spirava giorni dopo a Rikowo.
Episodi del martirio di Novaja.
A Novaja, per piegare l’ostinata resistenza dei nostri, i russi subirono gravi perdite. I pochi civili rimasti sul luogo mi dichiararono che i morti e feriti russi erano stati numerosissimi. Ma il nostro presidio locale venne quasi distrutto. Il 27 trovai quattro soli morti, dei nostri. Ne trovammo molti altri due mesi dopo, sotto la neve, in una fossa comune a nord del paese. Ed altri molti ne rinvenni dispersi qua e là sotto la neve, quando venne lo sgelo. In tutto raccogliemmo le salme di quarantadue Caduti. Da parecchi chiari indizi potemmo constatare che i feriti erano stati tutti uccisi.
Lo stesso, del resto, accadde ad Ivanovka, per i bersaglieri feriti, di cui uno solo si salvò. Mi raccontarono che la sera del Natale alcuni russi entrarono in una casa, dove giacevano alcuni bersaglieri. E cominciarono a portarli fuori ad uno ad uno. Quel tale, a cui ho accennato, sentiva lì fuori, di volta in volta, dei colpi d’arma da fuoco. Era ferito al dorso, ma le gambe le aveva sane. Quando capitò il suo turno, si lasciò condurre, fingendosi debole. Ma d’improvviso si gettò contro il russo che lo accompagnava e lo atterrò; e quindi si precipitò, in mutande ed a piedi scalzi, giù per la collina, inseguito subito dopo da raffiche di mitra, che fortunatamente non lo raggiunsero. E riuscì ad arrivare, stremato e congelato, nel caposaldo di Mikailowka.
Certo una simile sorte toccò al nostro Ernesto Zarotti a Novaja. Ferito al capo, era stato trascinato in un’aula delle scuole; ed un civile russo era accorso a portargli da bere. Io lo trovai il 27, ucciso da un colpo a bruciapelo al cuore, mentre il borghese russo, che mi si disse fucilato dai suoi connazionali, giaceva esanime contro il muro di un capannone poco fuori di lì. Qualcuno aveva rovistato nelle tasche di Zarotti; intorno a lui giacevano disperse le povere cose del suo portafoglio e proprio sul petto c’era uno di quei «Cuori di Gesù» in stoffa che si usan portare a forma di scapolare.

Un folto gruppo dei nostri risultò disperso; se non erro 72, che vennero fatti prigionieri. Di essi ritornarono in cinque: due legionari di Reggio Emilia nel 1946, il C.m. Codeluppi con gli ufficiali, e nel 1951 altri due legionari, uno dell’Emilia ed uno dei mitraglieri di Cuneo. Poco dopo gli aerei russi ci piovvero spesso addosso dei volantini di propaganda, in cui figuravano – tra i nomi di altri prigionieri italiani – anche quelli di alcuni dei nostri. Io non ero, l’ho detto, a Novaja. Gli episodi di eroismo e di reciproca dedizione che vi fiorirono in quella mattina mortale non si contano: ogni superstite ne narra a non finire. Ne ricorderò solo alcuni.
Il caposquadra Pelati Ezio era rimasto ferito all’apice polmonare destro. Il suo amico Giuliano Palmieri, che gli era anche coinquilino e compagno di lavoro nella vita civile, gli fu al fianco con fedelissima amicizia. E quando verso le ore 11, Tonolini diede l’ordine di sfollare i feriti, se possibile, verso Ivanovka o Mikailowka, il Palmieri si avviò verso est sorreggendo il Pelati. Riuscirono ad attraversare il boschetto, ma poco dopo caddero entrambi. Io li ritrovai due mesi dopo, quasi abbracciati in un eterno abbraccio. Nel 1943 tenni in Correggio una conferenza sui miei Caduti e raccontai, tra l’altro, questo episodio di amicizia fino alla morte. Alla fine della conferenza mi si appressarono due giovani donne vestite a lutto. «Chi siete?». Mi risposero: «Siamo le mogli di Pelati e di Palmieri». Mi si strinse il cuore. Non so perché, mi sentii dire: «E vi volete bene?». Allora si gettarono piangendo l’una nelle braccia dell’altra e dissero: «Come loro!».
Codogni Virginio era rimasto ferito alle gambe, e gli si eran dovuti togliere i pantaloni e le mutande per praticare la prima medicazione. Così, con gli arti inferiori ignudi, era stato messo a giacere su poca paglia entro una casa. Quando la furia della battaglia investì anche quella casa, un compagno, di cui non si sa il nome, se lo caricò sulle spalle e si avviò verso Mikailowka, nel tentativo di portarlo all’infermeria del Battaglione. Quel pietoso soccorritore riuscì a passare il boschetto; ma subito dopo una raffica gli uccise sulle spalle il ferito, che scivolò al suolo. Non sappiamo che cosa sia avvenuto dopo. Ma io trovai il Codogni ben composto nella neve: e sulle gambe ignude era stesa un’altra giacca, quella del soccorritore, come se avesse voluto vincere il freddo della stagione e della morte col caldo dono dell’amicizia. Pensate un po’ a quello sconosciuto legionario, che se ne va in prigionia in maniche di camicia per un gesto squisito di carità verso il cadavere dell’amico caduto!
E che dire del buon Mario Losi? Anche lui s’era avviato verso Mikailowka, sorreggendo un ferito. Se fosse stato un pavido od un egoista, si sarebbe salvato. Invece, per quella sua dedizione fraterna, morì. Il ferito, che egli portava, si salvò. Ed il povero Losi rimase fulminato nella neve.
Ma, a proposito di dedizione per i feriti, non posso non parlare di un portaferiti della 2a Cp., il «baffuto» Martini Agostino. Ecco che cosa ne scrivevo, lassù, poco dopo averlo ritrovato esanime nella tragica fossa di Novaja.
Erano certamente, i suoi, i baffi più belli di tutta la Legione ed egli fierissimamente li portava. Due cespugli biondi che si ergevano superbi, all’«umberta», verso due occhi chiari e virili. Un portaferiti eroico. Sordo alle mitragliate ed alle cannonate nemiche, sentiva soltanto il richiamo dei compagni colpiti. E una e due e sette volte corse dalla linea al posto di medicazione, trasportando a spalle i camerati che grondavano di sangue generoso.
Quando per l’ennesima volta si lanciò senza timore e senza riposo, a compiere il pietoso dovere, la morte lo fermò. Solo la morte lo poteva fermare. Un giorno vidi due baffi biondi come i suoi e ristetti a guardare, quasi sperando ch’egli fosse risorto. Il legionario che possedeva quei baffi dovette leggermi nel pensiero la folle speranza, perché mi disse:
– Signor cappellano, ho ereditato io i baffi di Martini.
E ne sentii una cocente tristezza. Allora capii che il mio biondo «baffone» era veramente morto.
Ma non la finirei più se volessi tutto raccontare. Permettetemi, tuttavia, che vi riferisca due ultimi fatti, che a mio parere hanno qualcosa di sublime. Uno lo trovo descritto così, nelle mie note di allora. Non posso assicurarvi la veridicità dell’episodio che sto per narrare, poiché so quanto è facile alla fantasia del soldato ricamare di leggenda un convulso momento di battaglia. Ma la tragica bellezza di quella mano, che s’agita per dire: «Non venite, non venite!», si è talmente scolpita nella mente che non so e non posso tacere. Ecco, dunque, quanto m’hanno raccontato alcuni legionari, mentre ce n’andavamo nel febbraio del ’42 alla ricerca dei Caduti nei gloriosi combattimenti del Natale.
«Vedete, signor Cappellano. Parecchi dei nostri sono discesi per questo canalone nell’intento di raggiungere il villaggio di Mikailowka. Scendevamo in ordine sparso per salvarci quanto più possibile dal tiro dei mortai russi. Una bufera infernale c’investiva da ogni parte cosicché non era difficile smarrire la via. E, quel ch’è peggio, non si sapeva più esattamente dov’erano gli italiani e dove i russi. Accadde perciò che qualcuno finì tra i nemici credendo di arrivare tra i nostri.
Quando giungemmo qui, allo sfociare del canalone, vedemmo gente muoversi su quella groppa di là della balka. Vedete: erano proprio là, ov’è quel gruppo di case, che ora sono note a tutti sotto il nome di Kolkos del miele, poiché vi trovammo miele a quintali.
«Qualcuno gridò: “Sono i bersaglieri”.
«Ma qualche altro, più cauto, disse: “No. Fate attenzione che sono russi”.
«In realtà non si poteva discernere bene chi fossero. Ci appiattammo, quindi, tra i cespugli e stemmo ad osservare.
«Anche dall’altra parte erano incerti. Ma infine, dalle grida, dal modo di gestire e dal colore dell’uniforme, dopo alcuni momenti d’incertezza, potemmo capire che erano russi per davvero.
«Erano russi: ma, credendo che non li avessimo riconosciuti, ci facevano cenni di richiamo, quasi per invitarci a passare il ruscello, come se fossero dei nostri.
«Ma allora vedemmo qualcosa che ci mise un brivido nelle vene.
«C’era tra loro uno che aveva un’uniforme diversa… Sì, era certamente un legionario. Intorno gli stavano quattro o cinque di quegli altri. Ed eccolo levare una mano ed agitarla per ammonire. “Non venite, non venite!”. Due o tre volte la mano si mosse disperatamente da destra a sinistra. Poi ci parve che quell’ignoto eroe venisse colpito da una pugnalata; e lo vedemmo precipitare a mani tese nella neve. Allora scaricammo tutte le nostre armi contro quel gruppo di nemici: chi non cadde fuggì e noi, sgombrata la via, potemmo raggiungere per di qui il reparto».
Molte volte ripassai, dopo la vittoria, per il “Kolkos del miele” e sempre mi fermai in stupita attesa, quasi mi fosse dato di vedere risorgere sul colle un gigante che agitasse la mano ad ammonire: “Non venite, non venite!”.
Ed ecco il secondo fatto, fragrante di quella istintiva umanità che accomuna i sofferenti e gli umili di là d’ogni barriera. Uno dei nostri feriti di Novaja, s’avviò solo verso Mikailowka. Ma i russi, avevano ormai tagliata la strada che conduceva a quel caposaldo. Perciò accadde che ad un certo momento la camicia nera venne a trovarsi sotto il tiro d’un gruppetto di nemici nascosto dietro un pagliaio. Il legionario si vide perduto: ma ecco sorgergli accanto dalla neve un russo – dico un soldato russo – il quale facendogli scudo del proprio corpo e prendendolo sottobraccio, gli fece capire con gesti che doveva imboccare un’altra via per salvarsi. E se ne andarono così, camicia nera e soldato russo, attraverso la bianca steppa.
Quando eran quasi giunti alla meta, una raffica che veniva dai suoi, colpì il russo, che s’accasciò al suolo. Il legionario si chinò su di lui per soccorrerlo, ma quegli insisteva perché lo lasciasse al suo destino e per conto proprio si mettesse in salvo nelle nostre linee ormai vicine. Allora il legionario, che sapeva di dover la vita a quell’infelice, benché fosse stremato anche lui, se lo caricò a viva forza sulle spalle. Ed entrarono così l’italiano ed il russo, nell’infermeria di Mikailowka, sorreggendosi fraternamente a vicenda.
La ripresa di Novaja Orlovka.
A Malo Orlovka fummo attaccati da sud la stessa sera del Natale. Ma resistemmo senza difficoltà. Ai russi premeva di far saltare quel cardine del portone che volevano spalancare. Intanto anche Mikailowka, circondata interamente, teneva duro con tranquilla bravura. E ciò significava il pieno fallimento dell’offensiva russa del Natale. Ai russi ormai non restava altra salvezza che ritirarsi.
Il Comando del C.S.I.R. intuì subito la situazione e decise di prendere in mano l’iniziativa. Perciò il 26 il 63° Btg. ricevette l’ordine di contrattaccare in direzione di Novaja. Partimmo, infatti. lo mi sentivo in cuore una grande smania di correre là, tra gli amici di Novaja, dove speravo di trovare ancora almeno i feriti, che i russi non avevano certo potuto mandare indietro e che non immaginavo avessero uccisi. Avevo già cominciato a scendere per la balka, quando arrivò l’ordine di rientrare. Una grossa formazione russa stava risalendo da Crestowka e noi non avevamo né uomini né armi a sufficienza per contrastarle la fuga con uno scontro allo scoperto, sulla pianura bianca di neve e piena di sole.
Rientrammo quindi ordinatamente a Malo. E qui, nel pomeriggio, fummo raggiunti da un grosso rinforzo della Divisione «Torino». Verso sera i russi in fuga ci attaccarono furiosamente da sud. Ma, ancora una volta, legionari e fanti ne ebbero facilmente ragione.
«26 Dicembre – Non dormito nemmeno un minuto – scrive nel suo diario il mio mitragliere caduto -. Vento freddo. Contrattaccato. Quasi tutto il giorno in mezzo alla neve. All’imbrunire attaccati per 2 ore e 30 minuti. Fatto un macello. Distrutta Divisione russa. Spezzonati e mitragliati 2 volte». Qui il mio povero Schiavi esagera un bel po’, dove parla di una intera Divisione distrutta.
Quella sera qualcuno mi trascinò fin sul tetto di una casa per assistere al combattimento. E lì feci una singolare constatazione. Nello stesso combattete si rivelava il diverso temperamento delle due formazioni. I fanti della «Torino», tutti giovani e di provenienza meridionale, mostravano la loro esuberanza nel clamore e nei movimenti affrettati. I nostri legionari, in media di parecchio più anziani e di provenienza friulana e piacentina, combattevano quasi silenziosamente, come sempre, e con gesti lenti e misurati. Tutti però con eguale bravura.
Al mattino del 27 uscimmo di nuovo per contrattaccare verso Novaja. Noi avremmo dovuto andare all’assalto e quelli della « Torino» seguirci di rinforzo. Andai a salutare il povero Mauro, ferito il 25, e lì vidi per la prima volta un cappellano militare, un cappuccino, che era con la «Torino».
Occupammo Scevcenko Ftoroi, dove facemmo qualche prigioniero. E fummo duramente attaccati dagli aerei russi. Noi non avemmo perdite; ma la colonna della «Torino» fu assai provata. Corsi indietro per dare i conforti religiosi ai più gravi, mentre i nostri sostavano in Scevcenko. Riprendemmo poi l’avanzata, scendendo nella valle e poi risalendo verso Novaja. Non trovammo resistenza. I russi erano scappati poco prima, ci dissero i pochi civili rimasti sul luogo, mentre andavamo sotto.
Io mi precipitai tra le case, da sud, un pressappoco dov’ero stato il 18, sempre nella speranza di trovare i nostri feriti. D’improvviso, alla svolta di una casa, vidi corrermi incontro qualcuno. Sostammo entrambi un attimo; e poi ci gettammo l’uno nelle braccia dell’altro. Era un caposquadra del 79°, che precedeva i suoi come un forsennato, per ricercare i due fratelli che appartenevano alla 2a Cp. e che non troverà più!
Poi mi diedi alla ricerca dei morti. Trovai «Gavinana» nella scuola; trovai tre altri caduti presso una siepe a sud-est, tra cui il soldato Canciani Angelo (eran i feriti che il sottotenente Zangrande aveva tentato di porre in salvo). E con quelle quattro salme sulle slitte mi avviai verso Mikailowka, ove rividi «Peder» e tutti i carissimi del 79°. Dormii accanto a Peder. La mattina mi fecero sapere che un radiogramma mi convocava di nuovo a Novaja, perché si doveva procedere nel contrattacco.
Mentre mi avviavo, m’imbattei nel ten. capp. Di Donno, dell’artiglieria, che quello stesso giorno avrebbe avuto una gamba spezzata da una scheggia di bomba d’aeroplano; bevemmo il caffè insieme.
Non andai solo verso Novaja. Per le vie di Mikailowka incontrai il legionario Anfossi Gio.Batta di Taggia (Imperia), che il 25 era stato fatto prigioniero dai russi e poi era riuscito a scappare. Gli feci le mie congratulazioni e mi mossi per continuare il mio cammino.
– Dove andate? – mi domandò.
Risposi che andavo a Novaja, dove il suo Battaglione si preparava per attaccare.
– Vengo anch’io – disse.
E andammo. Ma subito mi accorsi che zoppicava. – Cos’hai? – chiesi.
– Ho i piedi congelati.
– Ma allora fermati qui – esclamai – hai diritto di riposarti dopo la tua avventura.
Non volle saperne. E allora proseguimmo. Io davanti e lui, zoppin zoppetto, dietro.
A Novaja il Comandante del 63° Btg. non volle che prendesse parte all’attacco e lo costrinse – lui riluttante – a fermarsi lì. Quel giorno marciammo su Kurgan Ostri e su Voroscilova. L’Anfossi avrebbe dovuto farsi ricoverare all’ospedale. Invece pochi giorni dopo lo vedemmo arrivare lassù: voleva condividere coi camerati sino alla fine il rischio e la gloria. Questa e quello lo ebbero il 18 gennaio 1942.
In quel dì i russi fecero un ennesimo tentativo d’attacco contro Voroscilova e riuscirono ad infiltrarsi alle spalle dei nostri, minacciando l’accerchiamento. L’attacco fallì come sempre. Allora le artiglierie russe iniziarono su Voroscilova un terrificante bombardamento di punizione. Sul capannone di sinistra, «il capannone della morte», cadde una granata che ferì gravemente il C.M. Sandrigo Luca. Qualcuno gridò della disgrazia e l’Anfossi si mosse per andare in soccorso dell’ufficiale. Gli fu detto:
– Aspetta un momento che si quieti il tiro o che si sposti.
– Oh, non importa – rispose.
Andò e cadde schiantato da un altro obice.
CAPITOLO IV – Nell’inferno di Voroscilova.
L’attacco contro Kurgan Ostri.
Verso le 9 del 28 dicembre iniziammo l’attacco che doveva portarci a Voroscilova. A quanto ho sentito dire, l’attacco sarebbe stato sferrato su tre direttive. Alla nostra sinistra, 1’81° Rgt. della «Torino» da Malo Orlovka avrebbe puntato su Plotski (Oligovakta). Alla nostra destra i tedeschi di un Rgt. paracadutisti (quello stesso che aveva occupato Creta) avrebbe dovuto raggiungere Debalzewo. Il nostro 63° Btg., rinforzato da un gruppo mortai della «Torino», partendo da Novaja doveva conquistare la quota di Kurgan Ostri (il Colle Acuto) e il villaggio di Voroscilova, che giaceva un trecento metri più a nord, sul declivio settentrionale del colle. Delle tre colonne solo la nostra raggiunse l’obiettivo prestabilito. I fanti della «Torino », dinanzi all’accanita resistenza russa, ripiegarono al punto di partenza. Ed i tedeschi, bloccati nella vallata all’aperto, vennero duramente provati durante la notte dal congelamento.
Il 63° Btg. avanzò in formazione molto sparsa frontalmente. Era una giornata chiarissima per la neve, di sotto, ed il sole, di sopra. Stavamo già discendendo giù per la balka, quando da Kurgan Ostri cominciarono a tirarci addosso: ognuno di noi era un bersaglio chiarissimo per i mortai russi.
Io mi trovavo sulla sinistra, con la 3a Cp., come mi era stato ordinato. Bocconi nella neve, non potevamo muoverci, tanto il tiro nemico era intenso; ed a rimanere lì si rischiava l’assideramento.
Già si sentiva qua e là il grido dei feriti. Vennero colpiti allora Dean Umberto e Petris Giuseppe, che morirono entrambi due giorni dopo a Voroscilova. Mi precipitai dal comandante, il l° sen. Zuliani, e gli feci rilevare la nostra insostenibile posizione. Egli dette subito l’ordine di fare una conversione a destra, verso Ivanovka, per procedere verso la meta con movimento aggirante.
È inutile ch’io narri ora le fasi di quel combattimento. Ad Ivanovka presi un civile russo come guida – lo ritroverò tre mesi dopo a Slobodo Orlovo e mi farà un monte di feste -. E verso le 2 raggiungemmo di sorpresa la vetta di Kurgan Ostri, ove facemmo dei prigionieri nelle postazioni. Poi ci gettammo verso Voroscilova. Per fortuna i russi, invece di lasciarci accostare, ci scaricarono addosso le loro mitraglie quando eravamo ancora al limite di sicurezza. Ma ad un limite così preciso che bastava alzare la testa o la mano per essere falciati. E lì morirono Platè Pacifico e Ferrigutti Olivo, che avrei potuto raccogliere solo tre giorni dopo.
Volgendomi sulla neve, vidi che la mia guida russa se ne andava senza danno, stando carponi. Perciò feci altrettanto e corsi sulla quota, ove intanto era arrivato il grosso del Btg., per chiedere che venisse aperta la strada coi cannoni anticarro e coi mortai. Ma le munizioni non eran molte. Mentre veniva comandato un aggiramento di Voroscilova da est ed i nostri avanzavano a balzi, ecco apparire d’improvviso, dalla nostra destra, tre carri armati tedeschi, che andavano a liberare un altro loro carro, rimasto inceppato poco avanti in una precedente puntata.
Il comandante Zuliani si precipitò innanzi, gridando: «Sotto, sotto!». E, mentre i carri armati sparavano sulle postazioni russe, i nostri balzarono da destra e di fronte sul villaggio, che venne subito occupato. I russi superstiti precipitarono per la balka verso Nichitino, lasciando sul luogo molti morti e feriti e parecchi prigionieri, i quali ci dissero che se fossimo arrivati poco tempo prima avremmo catturato l’intero Comando di una Divisione.
Ma per i russi quel gruppetto di poche case, e soprattutto il Kurgan Ostri, avevano una grande importanza strategica. Perciò da quella notte stessa cominciarono quei rabbiosi contrattacchi e, tra l’uno e l’altro, quei micidiali tiri di mortai e cannoni che sperimentammo poi ogni giorno, fino al giorno 20 gennaio, quando la Legione ricevette il cambio dai bersaglieri. La storia di quei terribili giorni è presto detta. Resistemmo sempre. Resistemmo nonostante il freddo tremendo, le privazioni, gli accerchiamenti e le perdite ingenti.
I ventitre giorni di Voroseilova.
La conquista di Voroscilova ci costò i due Caduti già ricordati, Ferrigutti e Platè, e ventiquattro feriti. I contrattacchi russi cominciarono nelle prime ore del 29. Scrive nel suo diario Schiavi Orazio: «29 Dicembre – Dormito nulla. Nella notte furiosi contrattacchi nemici per riprendere la posizione… Morti russi ve ne sono molti nelle case e sul terreno. Attacco nemico all’alba durato tre ore. Tutto il giorno sparano cannonate e mortai che sembra il finimondo. Gli aerei ci sono sopra tutto il giorno a spezzonarci e mitragliarci …».
Il 29 dicembre avemmo quattro morti e quarantanove feriti, di cui tre gravissimi. I Caduti furono: il C.M. Meoli Luigi, il ten. Pregelio Ezio, il serg. Focaccia Mariano (questi due del nostro Btg. AA.) e la c.n. Conti Giuseppe. I tre feriti gravissimi furono: il cent. Luigi Mutti (che morì alle 14 del giorno dopo, all’infermeria in linea), e le cc.nn. Venier Quinto e Castagnoli Giuseppe che morirono alcuni giorni dopo all’ospedale da campo.
La sera del 29 ci raggiunsero a Voroscilova il 79° Btg. ed il Comando della Legione. Il 30 morirono: Leon Romano, il CM. Mazzocchi Amilcare e Cocetta Gio.Batta al mattino (altro furioso attacco russo); Castellani Giuseppe nel primo pomeriggio, per quel logorante cannoneggiamento pomeridiano che si ripeterà poi ogni giorno alla stessa ora; ed a sera Faverzani Renato. I feriti furono ventinove, di cui Benatti Silvio e Boldarino Elio morirono giorni dopo all’ospedale. Questo dì medicammo i due primi congelati.

Il 31, nel primo pomeriggio, vennero per qualche ora fino al caposaldo di Voroscilova i bersaglieri del 18° Btg. Quest’oggi noi avemmo un Caduto: Sicuro Ennio. Morì pure il bersagliere Ferri Antonio, tra i ruderi di una casetta dinanzi l’infermeria, e ne furono feriti altri sette, due dei quali tra le quote e Voroscilova, che andai a raccogliere col buon Mariano, perito in uno scontro stradale a Udine tre anni fa, e con un altro legionario del 79. I feriti della Legione furono soltanto sette; e cinque i congelati. Sette feriti ebbe pure il 26° gruppo mortai, che era venuto con noi alla conquista di Voroscilova.
Verso sera uscii a raccogliere i due Caduti del giorno 28, Ferigutti e Platè, coadiuvato da due o tre volontari, tra i quali il bravo e generoso Bortolin, che nell’agosto del 1942 avrebbe perso la vita nel soccorrere i camerati feriti. Mentre eravamo intenti al nostro mesto compito, al grido «Chi va là?» ci vennero appresso alcuni uomini a cavallo; uno di essi era il gen. Lombardi, vicecomandante della «Celere».

Il l° gennaio 1942 lo passammo senza la molestia dei contrattacchi russi, ma non senza la solita sarabanda del tiro d’artiglieria da Nichitino. I feriti però furono soltanto due; ma ben venti i congelati, per lo più di 2° grado, qualche volta del 3°. E qui, sia nel mio diario che in quello del mitragliere Schiavi, c’è per singolare coincidenza un eguale silenzio.
Lo Schiavi ricorda il giorno 6 gennaio: «il mangiare è arrivato dopo cinque giorni. Siamo senza coperte e vi è una tormenta di neve con un freddo terribile che dura da sei giorni. Molti congelati. La mia Compagnia (che era la 2a Cp. del 63°) di 117 ci siamo ancora in 35».
In mancanza delle note del diario, mi affido alla memoria. Ricorderò soprattutto la snervante fatica delle pattuglie, che da Vorooscilova andavano in turno a presidiare le quotine di Kurgan Ostri; al ritorno bastavan quei trecento metri contro vento per rientrare col volto in vesciche, dove non era protetto dal passamontagna. Ricorderò i tentativi russi di approfittare del «burian» per accerchiarci ed eliminarci; una volta parve stessero per riuscirei. Ricorderò come fossimo privati di ogni collegamento, anche telefonico, anche radiocampale.
Ed avemmo pure delle perdite. Numerosi i congelati. Parecchi i feriti, tra i quali, un giorno, Mezghez Rodolfo di Aidussina del 63° AA., colpito in modo non grave ad una gamba. Quando io aprii la porta per dire: «Avanti un altro», il Mezghez venne a porsi tra me e la finestra: in quell’istante cadde lì fuori una granata ed una scheggia ferì alla schiena il Mezghez, che mi cadde tra le braccia. Andrà a morire qualche giorno dopo all’ospedale da campo.
In quei giorni cadde pure ferito mortalmente Zoppi Vittorio, che spirò poi nelle mie braccia. Bisogna dare una lode, qui, ai nostri bravi legionari addetti alle slitte, che salivano nella bufera a portare viveri e munizioni e scendevano col carico tragico dei morti, dei feriti e dei congelati. Al pericolo delle pattuglie russe si univa il freddo terribile e il vento impetuoso. Non una sola volta le slitte si rovesciarono nella neve, ed era uno strazio sentire l’urlo dei feriti.
Il 6 gennaio allarme alle 2,30 ed allarme ancora alle 6 del mattino. Si sente sparare dal boschetto sulla sinistra e si vedono ombre muoversi nella nebbia, alle nostre spalle, fra Voroscilova e le quote. I mortai colpiscono più volte il capannone di sinistra e le artiglierie battono tutto il caposaldo. L’attacco è presto sventato. Cade Cantoni Erodiano, falciato da una mitragliata, mentre stava di vedetta; e altri sono feriti. Verso le 9, mentre ritornano dalle quote, cadono all’ingresso di Voroscilova, Dorini Mario e Purinan Pietro. Purinan ha ancora qualche gemito: ho tuttora presenti i suoi occhi chiari sbarrati… Dò loro l’assoluzione e l’Olio Santo e mi avvio verso Ivanovka, dove sono chiamato a benedire il cimitero in cui vengono sepolti i bersaglieri del 18° Btg. caduti a Natale.
La cerimonia si compie sotto la neve, che fiocca lentamente. Ed è una cosa dolce e triste sentire il col. Carretto, che fa l’appello dei Caduti; e di quando in quando, ad un nome, aggiunge il commento «Anche tu, povero figliolo!»
Poi andiamo a colazione. Il gen. Marazzani, comandante della Celere, mi fa sedere dinanzi a lui. Colgo un momento in cui gli altri sono distratti e gli comunico il rapporto del comandante della Legione: «A Voroscilova siamo in condizioni assai gravi. Gli uomini, dopo tante perdite, sono ridotti a tanto pochi, che spesso una mitragliatrice ha un solo inserviente. Ed anche i pochi superstiti, dopo dieci giorni d’inferno, sono stremati; reggono in piedi per un miracolo di forza di volontà. Abbiamo urgente bisogno del cambio!».
Ed il gen. Marazzani mi risponde, comprensivo, ma preciso: «Voroscilova non può essere abbandonata. E, d’altra parte, né i tedeschi né la Divisione vi possono dare il cambio. Perciò riferisca al comandante che l’ordine è di tenere fino all’ultimo uomo».
Risalgo verso le quote con quella risposta. E trovo il comandante Nicchiarelli ad attendermi al di qua delle quote. Poi su Voroscilova ricomincia il solito tiro pomeridiano; ed io mi affretto a ritornare tra i miei ragazzi. Il 7 cade Rivi Nello ed è ferito il cent. Margini. Altri feriti ancora. Tra essi il ten. Rebula del 63° AA., che ha una gamba spezzata; mentre il dotto Pappalepore lo medica, la gamba trema e lui non vorrebbe. « Ma è rotta, lasciala che tremi»! Non ha un lamento. Margini non vorrebbe lasciare la compagnia; siamo in troppo pochi, dice.
L’8 gennaio un grappolo di granate (la Katiusha!) cade sull’angolo SW del capannone, dove è una postazione di un cannone anticarro e di una mitragliatrice. Cade ucciso un caporale dell’8l° Rgt. Fanteria, venuto in collegamento; e mentre assisto lui ed il povero Scacchetti Ottorino moribondo (già ferito leggermente il 29), qualcuno porta a medicare Pin Angelo e Mazzini Italo delle AA. Entrambi moriranno, il Mazzini scendendo a valle sulle slitte e Pin Angelo all’ospedale da campo.
Il 9 gennaio cade Nironi Andrea ed è ferito a morte Corradini Glicerio. Ci son pure altri feriti, di minore entità. Il mitragliere Schiavi Orazio scrive:
«10 Gennaio – Sono due notti che non vi è l’allarme. Per la prima notte dormo bene in una camera con 4 dita di pantano. Non mi sono ancora slacciato le scarpe dal 27… In questi giorni ho pregato molto».
Invece, nella nostra infermeria, il dottor Pappalepore ed io ci mettemmo a fare la prima bella dormita il 10, all’ora del solito tiro russo pomeridiano. Avevamo un solo letto – cioè una rete metallica – e nessun ferito. Ci stendemmo perciò su quella rete, l’uno a fianco dell’altro. Quella casa era chiamata la «casa del miracolo», perché era stata arata intorno intorno dalle granate, ma colpita mai.
I russi aspettarono che ci fossimo addormentati per pioverci una granata proprio sul colmo sopra le nostre teste. Fummo sepolti, ma non accadde nulla. O meglio accadde che, accortici di non essere feriti – a piè del letto c’eran l’attendente di Pappalepore e l’aiutante di sanità – uscimmo tutti impolverati; e, mentre noi scendevamo un momento nel «progreb» dove stava il comando, gli «esploratori» ci esploravano quel po’ di cognac che c’era lì…
Ma dal giorno dieci cominciò un periodo di calma completa, che durò fino al 15. Io ne approfittai per andare a Mikailowka, ove ero stato chiamato a riconoscere certe salme, di cui era stato perduto – nel trasporto – la carta (quella entro il cotone), sulla quale ne avevo segnato i dati. Qui mi colse febbre violenta. E, per farla breve, dal 12 al 22 fui ricoverato all’Ospedale da Campo 837; e dal 22 al 25, se non erro, a Putilovka. Il 26 ne ripartii, passando per Jessinovataje, dove ebbi l’occasione di vedere alcuni nostri feriti. Ed il 28 rientravo al reparto, fermandomi a Katik.
Nel frattempo a Voroscilova il 15 si ebbe uno scoppio con incendio nella casa dov’erano i nostri mortaisti, con alcuni feriti, di cui uno grave. Ed il 18 gennaio i russi sferrarono un nuovo violento attacco, circondando Voroscilova e spingendosi fino a 50 metri dalle nostre postazioni. Come sempre, vennero duramente respinti. Ma alle 8 cominciò un rabbioso tiro di punizione. Fu un giorno terribile.
I nostri ebbero quattro morti: il CM. Sandrigo Luca, il csq. Spighi Antonio e le cc.nn. Anfossi Gio.Batta e Schiavi Orazio, l’autore del diario, il quale ha queste note estreme:
«15 Gennaio – Bruciata questa notte casa a 5 metri dalla mia. Un proiettile a granata scoppiato tetto mia casa, 1 ferito grave. Schegge entrate a 50 cm., battuta una forte in una gamba e non mi ha rotto».
«16 Gennaio – Due allarmi di pattuglie. Posta. Dormito 2 ore».
Il 20 sera i nostri ricevettero il cambio dai Bersaglieri del 18° Btg. Ma la mattina del 21 un violento attacco russo riuscì a sloggiarli. Essi non avevano l’esperienza del luogo e, d’altra parte, la strage subita il giorno del Natale e la visione – per 23 giorni – delle nostre teorie di morti, di feriti e di congelati non eran fatte per tener su il morale.
Venne allora dato l’ordine di riconquistare Voroscilova. Si doveva attaccare il giorno 25. I bersaglieri frontalmente ed una nostra Compagnia del 79° con aggiramento da nord. La sera del 24 il ten. col. Nigra, venuto da poco dall’Italia ad assumere il comando del 18° Btg. Bersaglieri, invitava i suoi ufficiali, tra cui il cappellano Don Davoli, a brindare all’onore del Battaglione. Fu una scena da storia greca.
Ma l’azione del 25 non riuscì. Essa vide l’olocausto di quasi tutti gli ufficiali dei bersaglieri, compreso il cappellano; e il sacrificio anche di sette dei nostri, che pure avevano raggiunto il loro obbiettivo e stentarono non poco a disincagliarsi dalla trappola, volgendo di là del boschetto di sud-ovest. Quei nostri ultimi sette Caduti di Voroscilova non poterono mai essere raccolti.
Finì così la vicenda di Voroscilova. I russi rioccuperanno anche Kurgan Ostri; ed i russi e gli italiani rimarranno attestati sulle posizioni che avevano avanti Natale, fino a che, nel luglio, non riprenderà l’offensiva, che doveva portare le truppe italiane – mutate da CSIR in ARMIR – fino sulle rive del Don.
CAPITOLO V – L’epopea di Voroscilova.
Palme nella galaverna.
Vorrei raccontare, ora, alcuni tra i molti episodi di bravura e di fede, di cui furono attori i miei ragazzi a Voroscilova. Desidero premettere che tra noi non allignava la mala pianta della retorica. I miei uomini fecero quel che fecero senza atteggiamenti divistici, senza ostentazione di furori marziali o di slanci eroici. Notai, anzi, che chi s’era dato delle «arie» prima del combattimento, nel momento della prova rivelò sovente una interiore debolezza. Ed invece chi era sembrato nelle retrovie un uomo da poco, e come tale era stato spesso trattato o addirittura disprezzato, dinanzi alla morte si palesò un tranquillo eroe.
I nostri uomini erano antiretorici anche perché piuttosto anziani d’età (la media era superiore ai trent’anni), per la maggior parte sposati. Lo erano altresì per il loro temperamento regionale piuttosto positivo e freddo, con una certa eccezione per gli Emiliani, o parte di essi, che sono – come è noto – di sentimenti più lirici ed esuberanti.
Tutti i legionari avevano però un amore patrio puro e profondo, una fede religiosa sostanziale ed un cosciente altissimo senso del dovere e del sacrificio. S’era poi diffusa tra noi e ci aveva compenetrati una singolare poesia, uno spirito di corpo ed un affiatamento, che furono di impareggiabile aiuto per superare tante prove. Tali qualità finirono per imporsi a tutti: anche a coloro che non le avevano sapute intravvedere, anche ai commilitoni degli altri reparti italiani, anche ai tedeschi, anche ai russi. Se volessi parlare di episodi, di cui furono protagonisti i legionari tuttora superstiti, potrei riempire molte pagine.
Dalle mie note, scritte durante le medicazioni nella infermeria, dal 28 al 31 dic., colgo per esempio questi brevi appunti: Il mitragliere R. E., ferito, grida all’amico Pagani: «Prendi su anche le mie bombe, daghe soto». M. F., appena medicato, dice: «Torno a fare le schioppettate, perché sono a pochi metri». Al fante anticarrista S. R. domando: «Come va laggiù»? Risponde: «Spariamo a zero! Ma non ce la faranno». N. A., ferito da schegge ad una mano, rifiuta di andare all’ospedale. C. G. si presenta dopo 24 ore dalla ferita: «Prima non potevo. Eravamo rimasti in pochi e i russi si facevano sotto». L. M., ferito alla coscia, dice: «Fate presto, che devo tornare all’arma»! Ed il mortaista M. N. del 63° AA., rimasto solo a tre pezzi, saltando indiavolato dall’uno all’altro allo scoperto, li faceva funzionare tutt’e tre e gridava in sardo: «’Ssa manu a ‘sa maniglia» – Ci vuole questa mano a questo volante.
Naturalmente ci fu anche chi ebbe paura. Paura e coraggio sono sovente un fatto in prevalenza fisiologico. Chi fu chi ebbe paura e non la vinse. Ci fu chi la ebbe e la dominò. Ci fu chi non ebbe neppure tempo d’averla, tutto preso dal suo dovere. Ci fu chi benedisse la pallottola o scheggia «intelligente» o l’opportuno congelamento. Ma l’indomita resistenza dei ventitre giorni e le gravi perdite (37 morti, senza contare i dispersi del 25 gennaio, oltre 120 feriti ed una ottantina di congelati) dimostrano eloquentemente, di là di ogni esaltazione retorica, la prodezza dei legionari.
Sarà opportuno ricordare che all’inizio dell’azione su Voroscilova, per le perdite subite dal Dnieper in poi, il 63° Btg. aveva perduto oltre cento uomini ed il 79°, con l’immolazione della 2a Cp. a Novaja, oltre duecento. Abbiamo già visto, dal diario dello Schiavi, che la 2a Cp. del 63° il 6 gennaio era ridotta a soli 35 uomini sui 117 effettivi. Con le perdite dei giorni successivi, specie del 18, discenderà a valle con poco più di una ventina.
Non c’era, dunque, nulla di retorico nel canto che un legionario compose, sulla falsariga d’una canzone di guerra, e di cui amo dare alcune strofe:
Venti giorni a Voroscilova Senza il cambio per dismontar!
Tapun, tapun, tapun – tapun, tapun, tapuun!
Dal mortaio di Nichitino Legionario non farti ammazzar!
Tapun, tapun, tapun – tapun, tapun, tapuun!
Quando poi che discendi al piano o Legione non hai legionari
Tapun, tapun, tapun – tapun, tapun, tapuun!
Per noialtri Voroscilova Redipuglia ci fai ricordar!
Tapun, tapun, tapun – tapun, tapun, tapuun!
Ma io desidero ricordare soprattutto, ai reduci, gli ultimi istanti di alcuni dei nostri Caduti. Un giorno, correndo a soccorrere dei feriti, vidi i rami scheletriti degli alberi così stellanti di ghiaccioli che mi parvero fioriti. Non avevo mai visto una galaverna tanto bella, né la vedrò mai.
Pareva che gli alberi facessero una anticipata primavera, se non ci fosse stato il freddo mortale a disingannare. E mi sembrò che fra tanto biancore sarebbe stato al suo giusto posto il verde dei palmizi. E coglierne le palme per ricoprire i corpi lacerati dei nostri Caduti, che avevo ammonticchiati nel caseggiato semidistrutto sulla destra; e ricoprirli di palme per ripararli dalla neve e perché ogni Caduto meritava una palma. Non potrò narrarvi la morte di tutti. Ma voglio rammentarvi quella di alcuni che ebbe un particolare fulgore.
Tenente e sergente insieme fino alla morte.
Il sottoten. Pregelio Ezio di Trieste, comandante un plotone di cannoni anticarro, era un carissimo e vivacissimo figliolo. Il giorno di Natale aveva fatto meraviglie a Malo Orlovka. Caro Pregelio! Quante volte mi disse: «Cappellano, quando torneremo a casa, devi venire tu a sposarmi». Si sposò con la morte la mattina del 29 dicembre.
In uno dei furiosi contrattacchi russi che cominciarono alle prime ore di quel giorno e continuarono fino nel pomeriggio, ad un certo momento la pressione s’era fatta quanto mai pericolosa. Pregelio sparava a zero coi suoi cannoni. Ma gli parve che occorresse orientare il tiro con maggiore efficacia. Perciò uscì dalla casa in quel piccolo atrio che si trova di solito dinanzi alle isbe russe, per vedere meglio le mosse degli attaccanti. Un suo sergente, Focaccia Mariano di Ravenna, gli gridò: «Non state lì, tenente. È pericoloso».
Pregelio era più giovane del Focaccia, che sentiva quasi il dovere di controllare l’audacia del suo ufficiale.
«Bisogna – rispose Pregelio – solo di qui si può regolare bene il tiro».
Allora Focaccia lo seguì. E tutti due caddero insieme; pare, anzi, o così almeno ritennero i soldati presenti, che rimanessero colpiti dalla stessa pallottola. Pregelio al capo, Focacia al cuore. La mente che aveva guidato ed il cuore che aveva seguito si spegnevano nell’identico istante.
Un morituro che sorride.
La mattina del 29 dicembre, il giorno dopo la conquista di Voroscilova, fu veramente infernale. In breve la nostra piccola infermeria rigurgitò di feriti. E non solo di feriti. Chi li aveva accompagnati si soffermava un poco per riprender fiato. O qualcuno ci veniva per attingere coraggio. Ad un certo momento la ressa fu tale da recare impedimento. E il nostro bravissimo dott. Pappalepore proruppe deciso: «Chi non è ferito corra subito alle postazioni. Se rimanete qui saremo spazzati tutti …».
Se n’andarono, dunque. Ma rimase lì, in piedi, uno che non pareva fosse ferito: il mio caro, semplice ed umile D’Antoni Mario. Non pareva ferito. Lo guardai e mi sorrise. Ed io allora osai dirgli: «E tu perché non vai?». Mi rispose: «Sono ferito anch’io, signor cappellano».
Non gli replicai nulla. Continuai ad aiutare il dottore nelle medicazioni. Ed il povero D’Antoni dovette restar male perché non mostravo maggiore interesse al suo caso. Ma sorrideva …
Poco dopo mi disse: «Signor cappellano, scrivete a mio zio dopo!».
Mio Dio, com’era terribilmente chiaro quel «dopo ». Alzai sbigottito il capo e gli chiesi: «Sei ferito gravemente?».
«Credo di sì», rispose. E sorrideva come se volesse scusarsi. Lo medicammo. E la sera se ne discese a valle.
Pochi giorni dopo il cappellano don Enelio Franzoni, dell’837° O.C. che andrà prigioniero nel 1943 e sarà poi decorato di medaglia d’oro, mi scriverà in linea questa biglietto: «Sento il dovere di comunicarvi che è morto presso questo ospedale la vostra C.n. D’Antoni Mario ed è morto come un santo». Fu l’unica lettera che ricevetti a Voroscilova. E se don Enelio sentì il dovere di scrivermela, la morte del mio buon Mario deve averlo colpito fortemente. Io ne ricorderò sempre il sorriso, quel sorriso!
Devo aggiungere qui che D’Antoni Mario era uno di quelli che tenevano su il Rosario, a sera, nel proprio plotone. Poiché occorre dire che i miei legionari dicevano il Rosario volentieri e quasi ogni sera. Ed io trovai nelle tasche di quasi tutti i Caduti la corona del Rosario, che mi servì benissimo a legame le mani perché non rimanessero scomposti nell’irrigidimento della morte.
Lo dicevano non solo in linea – od anzi, ovviamente, meno in linea – lo dicevano nei mesi che passammo in Italia prima di partire; lo dicevano sui camions nella marcia di avvicinamento al fronte; lo dicevano nelle postazioni sul Dnieper; e lo dissero i superstiti nelle isbe di Mikailowka. Il Vescovo di Cassano Jonio, mons. Barbieri, additò ripetutamente dal pulpito il contegno e la fede della «Legione che prega».
E pensate con quale commozione, dopo la morte di D’Antoni Mario o di qualche altro di coloro che «tenevano su il Rosario», io mi sentivo dire da qualcuno: «Signor cappellano, ho preso io il posto nella recita del Rosario».
Perciò, il giorno di Pasqua del ’42, dopo aver distribuito a tutti la S. Comunione, potevo dire con diritto queste parole: «Signor Comandante, se la “Legione che prega” è diventata, sulle bocche di tutti, la “Legione che combatte in silenzio” e la “Legione che non cede mai”; se la Legione è salita ai vertici così alti di tranquillo eroismo; se all’arrivo dei legionari i nostri commilitoni fanti, bersaglieri ed artiglieri ci fanno festa come ad amici su cui si può contare; tutto ciò è avvenuto per la ricchezza profonda di fede, che ha dato ai nostri uomini il lievito di tanta forza e di tanta dedizione…».
Ed il comandante Nicchiarelli ed il vicecomandante Formica, i quali avevano voluto ricevere anch’essi la Comunione dalle mani di quel cappellano, ormai in partenza, che s’era levata benedicente su tanti Caduti e li aveva composti poi nel Cimitero di Mikailowka, i nostri comandanti assentivano commossi.
La morte di Mutti e di Mazzocchi.
Era il pomeriggio del 29 dicembre 1941, un pomeriggio ch’è rimasto presente nelle nostre memorie come qualcosa di fermo nel tempo. Il cielo era grigio di neve pronta a venire. E neve era su tutta la terra; e neve sui cadaveri russi, macabri segni della nostra conquista di ieri; e neve sugli alberi, neve a ghiaccioli, che fiorivano di fantastici ricami tutte le rame, in una visione di magia.
Ma l’aria gelida scoppiava tutt’intorno come un tintinnio di vetri infranti: una rete di proiettili esplosivi tesseva di «ciac! ciac!» il silenzio, sullo sfondo del «tututum» baritonale delle nostre «Breda». Le scie luminose dei proiettili traccianti parevano giochi d’artificio.
I russi salivano dalla balka e premevano contro le sette case diroccate dove ci eravamo asserragliati. Era la sesta volta che muovevano all’attacco quel dì, per ritoglierci la posizione da cui erano stati cacciati la sera prima. La danza, cominciata alle tre del mattino, aveva raggiunto in quell’ora del pomeriggio il suo culmine più rabbioso. La sera incombeva ed il nemico voleva spuntarla ad ogni costo prima delle tenebre.
Mentre correvo verso le postazioni estreme, qualcuno mi gridò:
– Signor cappellano, è stato ferito il centurione Mutti.
Mi precipitai allora a compiere il mio dovere di sacerdote nella casa ov’egli si trovava e lo vidi già steso su di una barella nel corridoio d’ingresso. Un proiettile esplosivo gli aveva squarciato il ventre, mentre da una breccia stava osservando i movimenti del nemico per dirigere il tiro delle sue armi.
Tre ufficiali ed alcuni legionari gli stavano intorno. Appena mi vide, mi disse:
– Cappellano, mi sono già messo in pace con Dio.
– Va bene, Mutti, gli risposi. Sapevo che l’avresti fatto.
Poi, più che lo strazio della ferita, la coscienza di non essere più utile per la battaglia gli strappò un’esclamazione di tristezza.
– Sparatemi un colpo di rivoltella – disse -. Per me è finita ormai.
Ma se ne pentì subito e con una ineffabile delicatezza ed umiltà soggiunse:
– Perdonami, cappellano. Non dovrei dire davanti a te così, ma lo chiedo a loro -.
E fece cenno ai camerati.
– Coraggio, Mutti! – lo ammonii – muori da grande come sei vissuto da grande. Sei sempre stato così bravo: hai già dato una volta parte del tuo sangue per l’Italia. Sii anche ora egualmente generoso.
– Ma vedi – osservò – è sempre stata una mia teoria. Quando uno non è più buono a niente e anzi è solo d’impedimento…
– Lascia stare le teorie, Mutti. Non è momento di teorie questo, ma di coraggio. Che cos’è morire senza soffrire? Offri al Signore la tua vita per la Patria e…
Egli aveva un cuore immenso. Seppur severo e taciturno, chi non l’aveva visto sempre primo ad ogni rischio e ad ogni fatica? Non pareva affettuoso. Nascondeva l’affetto sotto una scorza burbera e rude. Ma per risparmiare i suoi ufficiali ed i suoi ragazzi s’assumeva i servizi più pericolosi e più pesanti. Stupenda anima di soldato!
Fu perciò che a quelle mie parole il suo spirito arse come di una fiamma improvvisa e, rompendomi l’esortazione, gridò o meglio cantò (poiché parve poi tutto un canto il suo parlare):
– Sì, cappellano. Muoio volentieri per la mia Patria. Ragazzi, ragazzi – gridava – tutti al vostro posto e nessuno si preoccupi di me. E anche voi – volgendosi agli ufficiali – correte al vostro posto.
Un ufficiale spronato da quelle infocate parole, balzò fuori e con la rivoltella in pugno trascinò i legionari, bombe alla mano, a ricacciare i russi già vicini. Ognuno si gettò alla mischia come se il sangue del capitano morente li avesse inebriati. Ed io mi chinai su di lui ad assolverlo ed impartirgli l’Estrema Unzione.
Poi dissi:
– Ora ti porteremo al posto di medicazione.
– No, cappellano – gridò – no: lasciami qui. Se mi vuoi bene, lasciami qui. Che nessuno abbandoni il suo posto per colpa mia.
– Ma nessuno abbandonerà il suo posto! Ti porteremo io ed il tuo attendente. Noi due non combattiamo.
E misi le mani alle stanghe.
– Cappellano – gemette – allora non mi vuoi bene. Se mi porti via, non mi vuoi bene. Lasciami morire tra i miei ragazzi.
A tali parole non potei resistere e lasciai le stanghe.
– Va bene – dissi – che il Signore ti benedica.
Poi mi volsi al suo subalterno, che gli doveva succedere nel comando della Compagnia, per trasmettergli un ordine verbale del Comandante di Battaglione.
– Il Comandante dice – cominciai – che qualora, sotto la pressione delle forze superiori del nemico, si rendesse necessario il ripiegamento da questa casa…
– Ma sei matto, cappellano? Non si deve cedere d’un passo. Coraggio, ragazzi, coraggio! Il nemico non deve avanzare d’un metro.
Perciò non mi fu dato neppur di finire. E così l’ordine che portavo non fu mai trasmesso.
Con le lacrime agli occhi dissi invece ai due ufficiali:
– Siete veramente meravigliosi!
E poi rivolgendomi ai legionari nelle postazioni gridai:
– Coraggio, ragazzi! Vedrete che il Signore ci aiuterà. Avete sentito il vostro centurione? Non sono passati mai, non passeranno neppure questa volta.
Forse, quando il centurione era caduto, i ragazzi avranno avuto un istante di sbigottimento e d’incertezza. Ma ora la sua voce eroica li aveva rinfrancati. Se ne stavano alle mitragliatrici pesanti e leggere con una calma che non saprei descrivere. Io ero ancora tutto commosso e vibrante, quando uno mi rispose in dialetto friulano:
– Eh, no pàssin no!
E pareva quasi mi dicesse: « Da bravo, signor cappellano! Non è il caso di riscaldarsi troppo».
Sì che io me n’andai, felice di vederli così sicuri. E infatti poco dopo i russi, nettamente respinti, scivolavano di nuovo giù per la balka verso nord.
Qualche tempo dopo il centurione veniva portato al posto di medicazione. Lì accorse subito il comandante Zuliani per abbracciarlo e dirgli, commosso, parole di conforto e di ammirazione. E medicato dal nostro «dottorino», egli cominciò a salire il suo calvario di morte che doveva durare ventiquattr’ore. Durante tale lunga agonia, non ebbe che stupende affermazioni di bontà e di fede. Ne fermerò qui qualcuna delle più significative.
Gli chiesi:
– Che cosa mandi a dire a casa? Hai qualche affare cui provvedere o qualche cosa da disporre?
– No – rispose – mi sembra d’aver sistemato tutto da prima. Di’ soltanto a mia moglie ed ai miei figli che mi dispiace di arrecare loro dolore con la mia morte.
Ed un’altra volta:
– Dirai a mio figlio ch’egli non era più per me mio figlio, ma il mio più grande amico.
E rinnovò l’offerta della sua vita a Dio dicendo: – Per l’Italia e per i miei figli!
Una volta s’accese presso di lui una piccola disputa tra due ufficiali. Egli pareva addormentato. Ma improvvisamente si riscosse e disse:
– Non bisticciatevi, ma vogliatevi bene.
Tutti noi ci guardammo negli occhi che si eran fatti d’un tratto più lucenti.
La mattina del giorno dopo i russi sferrarono un nuovo furioso attacco, che doveva fallire, però, come tutti i precedenti. Il posto di medicazione, una stanzetta di tre metri per quattro, era già affollata di feriti, quando s’affacciò alla soglia un giovane e carissimo ufficiale, intimo amico del centurione Mutti. Veniva, certo, a chiederne notizie, ma era impossibile che lo potesse avvicinare in quella ressa. Perciò gli dissi:
– Sei venuto a vedere di Mutti? Ha passato la notte abbastanza bene.
– Che cosa dici, cappellano? – protestò il centurione.
Ma poi comprese subito un cenno della mia mano ed a voce alta disse all’ amico, che non poteva vedere:
– Sì, Amilcare. Torna pure al tuo posto e fa il tuo dovere fino all’ultimo.
E l’amico, drizzandosi a quelle parole come sull’attenti, rispose:
– Va bene, Mutti! Basta seguire il tuo esempio.
Ed uscì fuori, in mezzo al fuoco. Mi fu detto che corse tra i suoi uomini come avesse smarrito il senso del pericolo; fece spostare un’arma ove il nemico premeva di più e, mentre correva ad un’altra postazione, cadde col capo trapassato da una pallottola. Eran passati appena dieci minuti dall’eroico colloquio con l’amico.
Mi fu portato morente. Mentre gli impartivo i riti purificanti della fede, la giovinezza gli gemeva sul labbro con gemito angosciato ed oppresso, come se non volesse andarsene, come se fosse tristemente sorpresa d’essere cacciata così presto dal corpo fresco e vigoroso. Era il nostro giovanissimo C.M. Amilcare Mazzocchi. Ma io non dissi a Mutti che l’amico lo aveva preceduto.
Nelle prime ore del pomeriggio, quando ormai la morte gli era sul cuore, chiesi per l’ultima volta al centurione:
– Che cosa mandi a dire ai ragazzi della tua compagnia?
– Di’ che stiano in gamba – rispose – e che io pregherò dal Paradiso per loro.
Morì alle 14 del 30 dicembre.
Mi tenni io il suo cappotto, con lo strappo di dove era entrata la morte. Me lo tenni come una reliquia. E quando un ladro, nel 1946, mi depredò di tutte le mie cose, mi dispiacque più di quel cappotto che di tutto il resto.

Il ferito senza gemiti.
La mattina del 30 dicembre fu ferito gravemente il vicecaposquadra Boldarino Elio da Lavariano. Era un carissimo figliolo, d’una estrema delicatezza interiore e di una profonda fede. Presidente di una Associazione giovanile cattolica e legionario esemplare, nel suo cuore si disposavano armoniosamente Dio e l’Italia. Armoniosamente! Egli era amantissimo d’ogni armonia; dall’armonie sonore della musica sensibile alle armonie silenziose che vibrano in un’anima sognante ed idealista. Io lo vidi tante volte mentre suonava la cornetta nella nostra bella fanfara: c’era allora nel suo volto un singolare raccoglimento, una strana intensità. E lo vidi tante volte pregare od accostarsi all’agape eucaristica: allo stesso modo e più profondamente rapito ed assorto. Oltre le note della musica perseguiva una dolcezza lontana: oltre il velo delle parole o del rito sacramentale egli vedeva Iddio.
Pure, una continua leggera tristezza pareva lo segregasse dalla vita e dai compagni: una malinconia tenue, come il pallore del suo volto, pareva già allontanarlo dai vivi verso le strade misteriose della morte. Soleva parlarmi con insistenza di due cose soltanto: del suo prete e della sua fidanzata; di colui che lo aveva educato e spinto a vette soprannaturali di virtù e di colei che, solo a ricordarla, gli riscaldava il suo buon cuore di fanciullo.
– Signor cappellano, vi ha scritto la mia fidanzata? Le ho detto che vi scriva. Desidero che voi le diciate qualche parola di conforto e benediciate il nostro amore.
Parlava del suo amore al sacerdote con un’incantevole purezza e semplicità. Venne dunque quella mattina, al posto di medicazione. Gli chiesi:
– Sei ferito gravemente, Elio?
Mi rispose, povero figlio:
– Non abbastanza per i miei peccati!
Ed era tanto buono! Pensai: «Se tanti fra noi, se tutti noi avessimo tale umiltà ed accettazione del dolore, come sarebbe santo il mondo!». Lo spogliammo. Una scheggia gli era penetrata in cavità nel costato destro. Gli dissi, quasi sussurrando:
– Vedi, Elio! Sei ferito come nostro Signore…
Qualche gemito gli usciva dalle labbra pallide. Allora osai invitarlo a tanta altezza d’offerta che poi n’ebbi quasi rimorso.
– Elio – gli dissi – tu hai avuto sempre tanta fede. Ti chiedo di dimostrarla ora. Non lamentarti! Offri in silenzio la tua vita ed i tuoi dolori al Signore per l’Italia. E non piangere!
Non mi rispose. Ed io temetti di essere stato crudele. Ma lì fuori, a trenta gradi sotto zero, gettati a mucchio per le terre, giacevano oltre sessanta feriti: non potevamo sgombrarli, né potevamo dar loro un po’ di brodo od altro da ristorarli, perché la battaglia ferveva da ogni parte. Solo un po’ d’acqua fredda: ed anche questa a rischio di morte, perché bisognava uscire sotto le granate per attingerla da un pozzo che un bel giorno fu colpito in pieno. Ed io temevo che i nervi dei feriti non reggessero a tanto inferno: temevo che il gemere creasse un contagio di avvilimento nei sofferenti e nei sani.
Già tra scoppio e scoppio delle granate scroscianti tutt’intorno si sentiva l’urlo di qualche ferito grave che metteva i brividi. Perciò gli dissi:
– Elio, tu che hai avuto sempre tanta fede non lamentarti! Medicato dalle sagge mani del nostro «dottorino», lo mettemmmo a giacere in un angolo.
Dopo alcune ore un legionario venne a dirmi:
– Signor cappellano, il vicecaposquadra Boldarino desidera parlarvi.
Mi recai tosto accanto a lui, e, piegato un ginocchio per cogliere meglio la voce fioca, gli chiesi:
– Che cosa vuoi, Elio?
– Che cosa scriverete – mi disse – a mio papà? (sapeva che io scrivevo ai genitori dei Caduti). Gli direte che non mi sono mai lamentato? Ho fatto come mi avete detto.
Confesso che non potei rispondergli: un groppo mi soffocava la voce. M’alzai senza parola; mi sentii confuso davanti a tanta grandezza d’animo. Egli aveva offerta la sua vita ed i suoi dolori per l’Italia senza neppure un umanissimo gemito di dolore… Lo vidi ancora di sfuggita: s’era levato su un poco per confortare ed incoraggiare i feriti che gli stavano vicini. Poi partì, a notte, via per la neve, sulle slitte ch’eran venute a portarci le munizioni e se ne ritornavano giù con un carico eroico e sanguinante. E seppi che come un santo morì all’ospedale da campo 235 di Stalino.
Dopo il mio rientro in Italia, lessi su «L’Avvenire d’Italia» un articolo intitolato: «Ho visto morire un santo»: era firmato da un sergente di sanità. Parlava della morte del nostro Boldarino. Ed io stesso ne scrissi qualcosa sul periodico «Credere».
Ed ecco una lettera che parla di lui e che amo riprodurre:
«Posta Militare 88, li 2-9-42. Rev. D. Biasutti, sul “Credere” del 9 agosto c.a. ho letto la commovente vs. narrazione intorno la morte di Elio Boldarini, ex-presidente dell’Ass. Giov. di Lavariano (Udine). Mi sento perciò in dovere di confermarvi l’ultima frase che dice:
“E seppi che come un santo morì all’ospedale da campo di… “, essendo io uno tra i pochissimi fortunati ad assistere al sereno suo trapasso da questa valle di lacrime alla Patria degli eletti.
Da cinque giorni mi trovavo ricoverato al 235 O.C., allora a Stalino. In due sole ore le sale del grande fabbricato si sono riempite di feriti provenienti da ogni settore del fronte. Forse il più grave dei barellati era appunto il vicecaposquadra Boldarini. Potendo muovermi, davo una mano ai poveri infermieri, che in quei giorni avevano il loro bel da farsi. Appena fu adagiato sul suo lettino, il mio sguardo s’è incontrato col suo ed ho intuito subito che non si trattava di un ferito come gli altri. Buona parte della giornata la passavo al suo capezzale e gli somministravo tutte quelle cure che il suo stato pietoso richiedevano.
I primi due giorni parlava non senza un po’ di fatica (povero Elìo, oltre alla grave ferita alla regione del fegato, aveva pure un principio di broncopolmonite) ed avevamo stretto una sincera amicizia.
Mi parlava molto spesso della sua cara Associazione; della adorata mamma sua e della buona fidanzata che tanto teneramente amava. Ha voluto, anzi, che scrivessi loro dando assicurazione che non era grave e che presto li avrebbe abbracciati. Mi ha fatto pure scrivere al ten. cappellano don Lionello Del Fabbro, zio della sua fidanzata, pregandolo di venirlo a trovare quanto prima.
Ricordo una frase che mi ha fatto convinto della sua anima eletta: “Grave è la mia ferita e grande è il dolore che provo per essa… Soffro… Soffro molto… Ma sono rassegnato, anzi contento di offrire a Dio ogni mio patire per l’avvento del Suo regno anche in queste terre avvelenate dal Bolscevismo…”. Per quanto potei capire dalle frequenti visite fattegli dal buon dottore, il suo stato peggiorava di giorno in giorno, anzi di ora in ora. Quindi cominciai a riordinare tutti i suoi oggetti personali, fingendo di fare un po’ di pulizia alle tasche. Elio, però, aveva capito tutto e mi sorrideva con quello sguardo sereno e penetrante. Ciononostante accettava gli auguri e gli incoraggiamenti che i visitatori gli rivolgevano e ringraziava raccomandandosi molto alle nostre preci.
Il giorno segnato da Dio per chiamare a sé quell’anima eletta è arrivato. Verso le ore 16 del giorno 12 gennaio c.a. il male toccò il vertice. Un rantolo gli serrava la gola… Aveva sempre molta sete… Mandai a chiamare il sacerdote perché lo avevo preparato a ricevere l’Estrema Unzione. Subito il buon Padre arrivò e gli disse alcune parole di conforto.
Gli fu risposto con voce flebile: “Grazie, Padre, mi sento preparato; somministratemi pure l’Estrema Unzione”. Tutti della camerata piangevano. Che insegnamento meraviglioso di unione continua di un’anima con la grazia di Dio ci ha offerto il caro Elio! Mentre gli bagnavo ancora la lingua arida, mi sussurrò un ringraziamento per quanto avevo fatto per lui e volle l’assicurazione che scrivessi al suo amato parroco ed agli amici di A.C.
Ai piedi del suo letto erano immobili, oltre il ten. cappellano, pure tutti i medici, gli infermieri e vari ammalati. Tutti guardavano quel giovane senza lamenti, dallo sguardo sereno e tranquillo. Ad un certo momento disse con molta fatica: “Lo so che tra poco debbo morire; muoio contento e tutto offro a Gesù; mi dispiace molto per la mia cara mamma, … ma la rivedrò lassù in Cielo”. Pochi istanti dopo l’anima sua volava a ricevere il premio meritato.
Tutti piangevano e non staccavano lo sguardo da quel volto sereno. Più d’una voce ha detto in quel momento: “E morto da santo!”. Ogni oggetto suo fu consegnato al Padre; solo volli tenermi un ricordo: il distintivo di A.C. che Elio portava nel taschino della giubba.
L’indomani ho scritto una lettera al suo parroco, facendo una relazione su per giù come questa, e spronando i suoi giovani a voler imitare il loro amato presidente che per loro era divenuto pure potente patrono… Pregandovi di volermi ricordare al Signore perché anch’io diiventi buono come Elio, vi porgo i miei figli ali ossequi ed auguri. Dev. cap. magg. Casarin Luigi».
Un giorno, molti anni dopo, una giovane donna mi s’avvicinò:
– Sono la fidanzata di Elio!…

«Andrò in Paradiso?».
Non avevo mai veduto una ferita così tragica e, per questo, quel giorno dissi, come non ero uso, una bugia. Zoppi Vittorio era uno dei pochissimi toscani facenti parte della mia Legione. Ed era per me un piacere conversare con lui e goderne la pronuncia vibrata, lo stile robusto e la facondia aspra ed amara. Poiché in verità, c’era dell’asprezza nel suo dire ed anche nel suo volto. Aveva dei lineamenti duri che potevano dare l’impressione d’un animo scontroso e ribelle. La bocca, virile ed asciutta, era chiusa entro le parentesi di due rughe, che erano quasi solchi, e davano una nota di dolore e di stanchezza a tutta l’espressione del viso. Né l’occhio, chiuso in se stesso e velato di diffidenza, migliorava il tono dell’aspetto.
Pure ci eravamo fatti amici. Nulla io feci più che ascoltarlo e, se ristava, sollecitarlo a parlare. Ma egli era irato con la vita e con tutto, forse appunto perché nessuno l’aveva ascoltato. E l’incomprensione subita gli aveva avvelenato il cuore. Così, parlando, diventammo amici. Ed eccolo venire, quel pomeriggio del 9 gennaio, al posto di medicazione. Era stato colpito al fianco sinistro da una scheggia di granata. Mio Dio! Quando gli ebbimo tolto la giacca, sentimmo il respiro misto al sangue scrosciare dai brandelli della camicia. La scheggia aveva asportato parte del fianco e fatto addirittura una caverna nel polmone.
Fui talmente esterefatto che non ebbi forza di dirgli una parola. Parlò lui.
– Signor cappellano – disse – cercatemi nel portafoglio la fotografia della mia bambina. Almeno questa fortuna ho avuto, di vederla prima di morire.
Cercai e gliela diedi, muto perché commosso. Egli la baciò ripetutamente e poi me la riconsegnò. Solo a medicazione finita, dopo che fu deposto sull’unico lettino che c’era lì, essendomi rinfrancato un po’ mi accostai a lui e… feci il peccato di bugia. A nessuno dei miei feriti, se gravissimi, avevo mai taciuto le loro estreme condizioni. Poiché se un uomo deve essere un uomo e far tutto da uomo, deve soprattutto morire da uomo.
Perciò era mio uso – com’era dovere – d’invitarli all’offerta della vita a Dio e di impreziosirne gli ultimi momenti con la sublimità del cosciente sacrificio.
Con lui fui vile. Dissi:
– Ecco. Vittorio! Ora sei stato medicato e questa sera te ne andrai giù all’ospedale e poi, col tempo, in Italia. Certo la ferita è grave, ma anche il biglietto di ritorno in Italia è una grande cosa e bisogna pagarlo caro.
Volse il capo verso di me e con occhi fermi e pieni di rimprovero mi rispose:
– Signor cappellano, non sono mica un ragazzo io! So che devo morire.
– Ebbene – dissi – se non andrai in Italia, andrai in Paradiso. Sia fatta la volontà di Dio.
– Davvero andrò in Paradiso? – chiese. E mi guardava stupito.
– Ma certo che ci andrai. Sicuro che ci andrai. Tu metti nelle mani del Signore la tua vita e chiedigli umilmente perdono di tutte le tue colpe. Io ti darò l’Assoluzione e l’Olio Santo e così tutto sarà fatto bene.
Congiunse le mani e si dispose con l’umiltà d’un fanciullo al grande momento. Quand’ebbi finito, vidi che occhi, labbra e volto lucevano pace e serenità. Era uno che se ne andava in cielo e pensai di farmene un intercessore lassù. Perciò gli dissi:
– E quando sarai in Paradiso, ricordati anche del tuo cappellano. Sai?
Rispose:
– Oh sì! parlerò di voi lassù come parlavo a casa quando andai in licenza.
Egli era ormai tale che il Paradiso gli pareva la casa e andare in Paradiso dolce cosa gli pareva, come andare in licenza. Né ho sentito mai parole di tanta e semplice poesia, né ebbi mai, per me, regalo più bello della sua promessa.
Poi soggiunse:
– Sentite. Io vi ho detto tutto di me, ma vi ho taciuto fino ad ora una cosa. Sentite!…
E sussurrando piano piano il suo ultimo segreto, sì che io dovetti chinarmi sulle sue labbra, mi disse quella cosa:… e fu tanto gentile e bella ch’io non ve la posso ridire…
Poi volle che chiamassi il I° sen. Patroncini, comandante del suo Btg., dal «pogreb» lì dietro l’infermeria. Venne, infatti. E Zoppi gli disse:
– Desidero chiedervi scusa, prima di morire, delle grane che vi ho dato.
Ed il comandante si chinò ad abbracciarlo ed a rassicurarlo poi volse il capo per non fargli vedere le lacrime che gli rigavano il volto.

Muoiono pregando…
La mattina dell’8 gennaio – come ho detto più sopra – vennero colpite in pieno due nostre postazioni, una di mitragliatrice pesante ed una di cannone anticarro, all’angolo sud-ovest del famigerato capannone. Io accorsi e mi dedicai a dare gli estremi conforti religiosi ad un caporale dell’81° Rgt., venuto per collegamento, colpito da una scheggia al capo, ed al povero Scacchetti, dal ventre squarciato ed in fiamme. Poi rientrai all’infermeria. Ed ecco lì, sulla sedia, il soldato Pin Angelo delle nostre AA. Il dottor Pappalepore sta in quel momento tagliando il calzettone ed un lembo di pelle, che tiene ancora legato il piede destro alla gamba, stroncata in pieno da una scheggia; e poi getta la scarpa insanguinata, col piede dentro quasi ancor vivo, nel secchio dei rifiuti.
Volsi il capo da quell’orrida vista. E Pin Angelo è lì, con la testa riversa sulla spalliera della sedia. Alcune gocce di sudore gli brillavano sulla fronte pallida.
È lì e prega:
– Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto…
Non ha un gemito, non un lamento. Prega.
Povero Pin! Andrà poi a morire anche lui all’O.C. 837. Anni dopo io ne conoscerò il vecchio padre.
Quello stesso giorno venne portato all’infermeria Mazzini Italo da Mercato Saraceno in quel di Forlì. Una scheggia gli era penetrata nei polmoni, da un largo squarcio nella schiena. Il medico lo curò con la solita calma e perizia. Poi lo mettemmo a giacere sull’unico letticciolo che c’era lì e che era riservato al ferito più grave.
Ed il buon Italo gemeva ripetutamente, con gemiti piani e lunghi, pervasi da strazio e tristezza. Ogni movimento respiratorio doveva causargli spasimo, per quello scabro ingombro, che lo lacerava dentro. Gemeva e invocava:
– Ah la mia Eva e le mie bambine! Ah la mia Eva e le mie bambine!
Ricordava la moglie e le figliolette lasciate nella diletta Romagna e pensava che l’avrebbero atteso invano di ritorno nella casa e tra le amorose braccia.
Mi accostai a lui e gli dissi:
– Sii bravo, Italo. Non vuoi che le tue bambine crescano brave e buone?
– Oh sì! – rispose.
– Ebbene – soggiunsi – offri la tua vita al Signore per loro. Ed il Signore le farà crescere come vuoi tu. E tu continuerai ad essere il loro papà dal Paradiso, da dove le assisterai e le guiderai. Vuoi, Italo?
– Sì! – rispose. E da allora stette quieto e raccolto, mentre io gli impartivo l’Assoluzione e gli amministravo l’Olio Santo.
Poi, dopo avergli sussurrato altre parole di conforto e di fede, lo lasciai per attendere ad altri feriti. Né lo sentii più gemere. Fu qualche tempo più tardi che nella tragica stanzetta si levò ancora la sua voce, fatta chiara e squillante come quella di un giovinetto:
– Madonnina che ho tanto pregato – disse – accoglimi tra le tue braccia in Paradiso!
Io ne rimasi sorpreso e commosso. E mi volsi a guardare il medico negli occhi. Li aveva lucidi anche lui. Eppure eravamo abituati da tanti giorni alla morte. Intanto, forse, nel lontano borgo di Romagna una mamma diceva alle sue bambine: “Ora reciteremo un’Avemaria per il babbo».
E le innocenti bisbigliavano con le voci serene: “Ave, Maria, piena di grazia… ». Ed ogni loro parola diventava gradino d’una scala di luce che s’affondava nel Cielo. Su di essa saliva, con la povera schiena spezzata, Mazzini Italo, un soldatino d’Italia; ed in cima c’era la Madonna che lo aspettava a braccia aperte.

Tra i nostri feriti negli Ospedali da Campo.
Il 13 gennaio venni ricoverato anch’io all’O.C. 837 di Sugress. Qui, qualche giorno dopo, il cap. medico dott. Busato, ora professore all’Università di Bologna, mi raccontò che ai primi del mese vi era stato ricoverato un nostro mitragliere con congelamento di 3° grado. Si trattava del caso più grave che si fosse presentato in quell’ospedale.
Dice il dottore, al legionario, quasi con voce di rimprovero:
– Perché hai atteso di ridurti in queste condizioni? Dovevi venire prima, quando il congelamento era agli inizi.
Ed il nostro mitragliere risponde umilmente:
– Non mi è stato possibile, dottore. Ero rimasto solo alla mitraglia. Gli altri erano tutti morti o feriti…
Disse così: né credette di dire parole eroiche.
Il medico rimase stupito da tanta semplicità. Poi scriverà al nostro Comando segnalando quel bravo ragazzo per una ricompensa.
La sera del 19 vedo arrivare all’ospedale Carletti Amelio, con le membra lacerate da molteplici ferite. Una scheggia – tra l’altre – l’aveva colpito al capo che sanguinava attraverso le bende. Capii subito ch’era gravissimo. Ma rimasi profondamente commosso dal suo spirito elevatissimo.
– Li abbiamo respinti anche questa volta. – mi disse appena mi vide.
– E tu come stai? – gli chiesi.
– Sono un po’ malconcio – rispose – ma li abbiamo respinti…
E cominciò a raccontare, con una voce fatta acuta e vibrata dalla febbre che l’ardeva. Dovetti interromperlo.
– Stai quieto ora. Hai fatto il tuo dovere in combattimento. Adesso devi fare il bravo anche qui. Mettiti calmo e riposa per guarire più presto…
Il giorno dopo alle 6 del mattino vennero a chiamarmi.
– Signor cappellano, Carletti muore.
Balzai dal letto e gli corsi vicino. Era ormai agli estremi.
Mentre stavo mormorando una preghiera, volsi lo sguardo per caso ai suoi piedi e vidi che erano legati con nastri di garza alle sbarre del letto. Quella vista mi diede un’immensa pena e quasi rudemente domandai al capo infermiere:
– Perché l’avete legato così?
– Abbiamo dovuto farlo, signor cappellano. Non lo si poteva trattenere. Voleva ritornare in linea col suo Battaglione e gettava continuamente i piedi fuori delle sponde.
– Ma ora potete slegarlo – dissi.
Poiché se n’era già andato via. Non alla battaglia, ma al premio; non al fronte, ma al cielo.
La notte tra il 21 ed il 22, nello stesso ospedale, sta morendo il mio caro Benatti Silvio, ferito il 30 dicembre a Voroscilova. Benatti Silvio, l’instancabile pattugliatore e l’eterna vedetta del plotone comando. C’era una linea telefonica da rivedere? Chi andava? Lui. Un rastrellamento da fare? Ecco Benatti. Lo trovavi sempre presente quando c’era da faticare e da rischiare.
Un giorno m’aveva detto:
– Signor cappellano, mi sembra che i pantaloni vi cadano troppo sui ginocchi. Ecco qui qualcosa per tenerli su.
E mi dà una larga cintura di cuoio con un fermaglio di ottone su cui era impresa un’ancora incrociata da falce e martello e illuminata dalla stella comunista.
– Tenetela – mi dice – come un mio ricordo. Ogni volta che l’incontravo, gli gridavo:
– Ohilà, brutto, come va?
E lui:
– Ecco, ogni volta che mi vede mi strapazza!… Restituitemi la mia cintura! Se non fosse per merito mio, vi cadrebbero persino i pantaloni.
Povero caro Benatti! Ora muore. E nel delirio si agita e chiama:
– Don Biasutti, fermateli! Perché non li fermate? Fermateli!
Vuole che fermi i russi ch’egli vede nel delirio avanzare. Allora gli carezzo la fronte sudata e gli dico:
– Sta buono, Benatti. Non vedi che li abbiamo fermati? Ecco. Vedi? Vedi come fuggono!
Sorride: e muore.
Il 28 gennaio, passando da Jessinovataja per ritornare in linea, vado a trovare alcuni nostri feriti.
È con me il cappellano dell’ospedale. Quando arriviamo ad un letto, il legionario investe il cappellano così:
– Sono arrabbiato con voi.
– Oh, perché mai?
– Perché quest’oggi vi siete dimenticato di portarmi la Comunione.
– Ma se ti sei comunicato domenica scorsa?
– E cosa vuol dire? Oggi è il primo venerdì del mese.
Poi ci allontaniamo. E il cappellano mi osserva:
– Hai sentito? Puoi andare orgoglioso dei tuoi ragazzi. Sono pieni di fede e coraggiosissimi. Quello lì è un allegro chiacchierone che mi tiene su il morale di tutta la camerata. Ha avuto giorni brutti. Soffriva atrocemente e pareva dovesse andarsene. Ma nessuno lo ha sentito lamentarsi. Quando i dolori lo martoriavano di più, ce ne accorgevamo subito perché smetteva di parlare: se n’accorgevano tutti, poiché la camerata diventava tristemente silenziosa senza le sue barzellette ed il suo riso. Allora mi accostavo alletto per confortarlo. E lo trovavo con gli occhi chiusi e le mani giunte sul petto. Se ne stava quieto quieto: solo le labbra si muovevano. Pregava.
Generosità.
Non meno dell’eroismo e della fede rifulse la generosità dei legionari. Il l° seniore Patroncini, comandante del 79° Battaglione, promosse tra i suoi ragazzi l’iniziativa di un fondo per gli orfani dei Caduti. La proposta fu accettata con l’usuale entusiasmo che gli emiliani mettevano in ogni cosa, e furon raccolte decine di migliaia di lire.
Pochi giorni prima del Natale un legionario mi avvicinò e mi disse:
– Signor cappellano: mi è venuta un’idea. Se fossimo a casa, in occasione delle feste compreremmo un regalo ai nostri bambini, alle nostre spose, a qualche persona amica. Ora, invece, non possiamo. Ma, in compenso, non potremmo dare un marco (il soldo ci veniva dato in marchi-rendita ed un marco equivaleva a Lit. 7,60) a voi perché lo destiniate a qualche opera buona?
– Bell’idea! – risposi – Invierò la vostra offerta per le Missioni, poiché i Missionari sono i legionari e gli arditi della Fede. Parlatene tra voi privatamente e Dio benedica il tuo pensiero.
Furon raccolte parecchie migliaia di lire. Ricordo questo toccante episodio. Un giorno, a Voroscilova, uno mi disse:
– Signor cappellano, io non vi ho potuto dare ancora il marco del Natale (lo chiamavan così). Eccolo adesso.
– Aspetta – dissi – che prenda nota del tuo nome.
Mentre l’altro mi dettava il nome, sentii uno ai miei piedi gridare:
– Prendete anche il mio nome! Perché non prendete anche il mio nome? Vi dò il marco anch’io.
Era un ferito grave che aveva il cranio trapassato da una scheggia. Aspettava la morte, ma non voleva morire senz’aver dato il suo «marco del Natale».

Costruzione del Cimitero a Mikailovka.
Il 23 gennaio da Sugress venni inviato all’ospedale di Putilovka. Ma il 26 arrivò l’ordine di sgomberare, per una infiltrazione russa verso Griscino, che invece fu subito tamponata. Ottenni di rientrare al reparto. A Jessinovataja il Cappellano Capo resistette; ma il Colonnello comandante la sanità disse: «Se lo spirito vuole, il corpo segue».
Fui però sottoposto a visita e ne risultò un tasso di sangue come a Mantova e infiltrati polmonari. Sostai un po’ a Katik, dov’era il Comando ed il 79°; ed ai primi di febbraio risalii a Mikailovka, dove cominciammo la faticosa ricerca dei Caduti del Natale a Novaja e per gli anfratti.
Poi ci mettemmo a costruire il Cimitero. Vi ebbi dei bravi collaboratori in un gruppo di legionari del 63° con qualcuno del 79° ed in alcuni genieri, che ci aiutarono a far le mine per rompere la terra gelata.
Il Cimitero che facemmo nel marzo 1942 – con una croce di legno dai bracci legati simbolicamente a corona – arrivava fino alla fossa 87, quella di Gonzaga Amaldino, che avevo trovato morto, sotto la neve, col capo nell’acqua di un ruscello, come vi si fosse chinato a bere. Nella bella stagione venne sistemato assai meglio da Don Cante e vi furono aggiunte 42 fosse coi morti negli ospedali o nell’azione del luglio ’42. Vi mancano però i nostri 16 Caduti prima di Gorlovka.

Testimonianze sui Legionari.
Oggi non è facile poter ricordare le gesta dei legionari. Oggi, forse, non si osa neppure nominarli. Ho letto recentemente, su uno dei più grandi quotidiani d’Italia, una rievocazione della battaglia del Natale 1941: dei legionari neppure una parola! E tutto per un pezzettino di stoffa nera sui risvolti della giacca. Benché, in verità, un terzo almeno, i nostri fanti delle AA. ed i nostri autieri, non avessero neppure quella mostrina. E benché una buona parte dei legionari stessi non avessero mai avuto da fare con la politica; parecchi, infatti, erano stati arruolati con le ultime ammissioni al partito fascista e non pochi erano dei riformati dall’esercito. Ma vent’anni fa tutti dovettero riconoscere la lealtà e la bravura di quei ragazzi.
Tra le tante testimonianze, mi piace ricordarne una, quella di un ufficiale d’aviazione:
«Le camicie nere le incontrammo a Stalino, quando una squadriglia fu mandata lì, con i soli suoi mezzi, e rifornita solo per via aerea, perché così era necessario. Le CC.NN. avevano occupato il campo in ventiquattro, dopo averne fugato gli ultimi russi. Ed erano tutti uomini anziani, verso i quaranta…
Sapevano tutto quello che noi non sapevamo. Come si fa ad arrostire una galletta al fuoco vivo della fiamma, perché diventi biscotto; come si fa un lume con una scatoletta di carne; come si fanno lavorare i russi senza far prepotenze, senza usare la frusta e senza minacciare nessuno (l’unica volta che ho visto dei russi di buon umore erano dei conducenti di carretti requisiti dalle CC.NN. per i servizi del campo); e come si ovvia a forza di cavalli alla mancanza assoluta di automezzi…
Quante cose sapevano fare le CC.NN.! Anche far da mangiare per tutti, quando il campo divenne una specie di stazione aerea…; anche suonare la fisarmonica e la chitarra come non ho mai inteso suonarle in vita mia; anche essere decenti senza avere il corredo che era restato con la Legione, andata avanti mentre loro erano rimasti a conservarci il campo. Così quando… le ventiquattro CC.NN. se ne andarono verso il fronte, a noi rimase nel cuore una nostalgia che non doveva passare mai più» (così Enrico Meille in “Ali di guerra, n. 18, anno II; 25-II-1942-XX, pag. 12, Roma, Piazza del Popolo, 18). Quei ventiquattro andarono poi ad immolarsi il giorno del Natale nel caposaldo di Novaja Orlovka.
Ed abbiamo due altissimi testimoni non immemori del valore dei legionari: il maresciallo Giovanni Messe, comandante del C.S.I.R., ed il generale Mario Marazzani, comandante della Divisione «Celere». Potrei parlare del lungo colloquio col maresciallo Messe a Jesssinovataja, al momento del mio rientro in Italia. Ma lui stesso ne parlò ai legionari nel suo discorso a Makejewka. E potrei narrare quel che mi disse dei mie ragazzi il generale Marazzani a Lauzacco, nell’agosto del 1943.
Ma mi piace chiudere con una singolare testimonianza sulla «umanità» dei nostri legionari, che non temette rimproveri dai russi.
Un nostro mitragliere, B. F. di Cuneo, rimasto tra gli ultimissimi prigionieri (era stato catturato a Novaja nel Natale ’41), tra quelli considerati «criminali di guerra», venne sottoposto a lunghi interrogatori ed accusato di aver partecipato a rapine e che so io. Egli rispose fieramente: «Noi non abbiamo mai fatto male a nessuno. Portatemi nei luoghi dove siamo stati, nelle case dove ho abitato, e vedrete che nessuno mi accuserà». «Ti voglio prendere in parola – gli disse il commissario politico -; vedrai che ti faranno a brani ».
E lo portarono nei dintorni di Gorlovka. E gli fecero sfilare dinanzi la gente del luogo. C’erano di quelli che lui riconobbe e che, a loro volta, lo riconobbero con qualche strizzatina d’occhi. Ma tutti risposero concordi che quel soldato non aveva fatto loro nulla di male, che addirittura non lo conoscevano.
L’animo umano è quello che è. Ma sono certo che potremmo ritornare ovunque siamo stati e vi saremmo accolti con rispetto. Se ci lasceranno ritornare a raccogliere i nostri morti, ne potremmo dare la prova. Poiché la nostra vittoria più indiscutibile la riportammo nel cuore della gente russa, come del resto tutti gli italiani che furono lassù, dando prova della nostra cristiana ed italiana bontà. Ed anche in questa vittoria spirituale i miei ragazzi non furono secondi a nessuno.
Commiato.
Ho voluto narrare, o piuttosto ricordare a voi, miei carissimi Reduci, alcune tra le tante vicende che vivemmo assieme vent’anni fa. Vi ho voluto ricordare soprattutto la fine gloriosa dei nostri Caduti. Siamo tutti di vent’anni più vecchi. E forse non siamo migliori di allora. Il vento della vita ci ha dispersi qua e là. In regioni diverse, in occupazioni diverse, in situazioni economiche diverse, ed anche in diverse posizioni politiche.
Ma potremmo ritrovarci ancora nella stessa Fede, nella stessa poesia, nella stessa bontà, nella stessa fraternità di vent’anni or sono. Dobbiamo ritrovarci certamente nella stessa affettuosa memoria dei nostri Caduti. Per tutti coloro che caddero al nostro fianco prima di Gorlovka, per quelli che caddero dopo Debalzewo, sulle anse del Don, od in prigionia, per tutti i nostri Caduti, entriamo spiritualmente insieme nel Cimitero di Mikailowka.
«L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda su di essi la Tua luce perenne. Riposino in pace!». C’è un luogo, o carissimi nostri Caduti, dove voi siete tutti assieme: nel nostro cuore!

Elenco dei Caduti sepolti nel Cimitero Militare italiano di Mikailowka.
1 Serg. Focaccia Mariano; 2 S.Ten. Pregelio Luigi; 3 C.Man. Meoli Luigi; 4 C.Man. Sandrigo Luca; 5 C.Man. Mazzocchi Amilcare; 6 Cent. Mutti Luigi; 7 Cent. Gentile Mario; 8 C.Man. Barale Ezio; 9 C.S. Tibaldi Natale; 10 Ignoto; 11 Ignoto; 12 Ignoto; 13 C.N. Benatti Dante; 14 C.N. Accorsi Ermes; 15 C.N. Pregnolato Luigi; 16 Cpl. Casagrande Arrigo; 17 V.C.S. Petris Giuseppe; 18 C.N.S. Scacchetti Ottorino; 19 C.N. Dean Umberto; 20 C.N. Faverzani Renato; 21 C.N. Ghizzoni Martino; 22 C.N. Facchin Battista; 23 C.N. Mazzini Italo; 24 C.N. Nironi Andrea; 25 C.N. Zoppi Andrea; 26 C.N. Giustini Giorgio; 27 C.N. Basso Carlo; 28 C.N. Cavicchia Giovanni; 29 C.N. Palmieri Giuliano; 30 C.N. Codogni Virginio; 31 Ignoto; 32 C.S. Spighi Antonio; 33 V.C.S. Sicuro Enio; 34 C.N. Salami Angelo; 35 C.N. Purinan Pietro; 36 V.C.S. Platè Pacifico; 37 C.N.S. Conti Giuseppe; 38 C.N.S. Cantoni Erodiano; 39 C.N. Zucchini Goffredo; 40 C.N. Ronutti Giovanni; 41 C.Sq. Pelati Ezio; 42 C.N. Bassi Adelmo; 43 C.N.S. Schiavi Orazio; 44 C.N.S. Anfossi Giovan Battista; 45 C.N. Magnani Carlo; 46 C.N. Tosello Luigi; 47 Art. Giorgi Aldo; 48 C.N. Losi Mario; 49 C.N. Rivi Nello; 50 Soldo Rizzi Mario; 51 C.N.S. Ellena Giovanni; 52 V.C.S. Bertuzzi Renzo; 53 C.N. Bazzotti Rinaldo; 54 C.N. Benzi Valdeno; 55 C.N. Casalini Roberto; 56 C.N. Giuliani Argentino; 57 C.N. Sassi Ermes; 58 C.N. Carraro Enzo; 59 Art. Carlini Andrea; 60 C.N. Martini Agostino; 61 C.N. Magnani Leonardo; 62 C.N. Dorini Mario; 63 C.N. Veroni Ardilio; 64 C.N.S. Frencia Alfredo; 65 C.N. Ragazzoni Giuseppe; 66 V.C.S. Rossetti Egidio; 67 C.N.S. Castellani Giuseppe; 68 C.N. Tamai Alessio; 69 C.N.S. Zarotti Ernesto; 70 C.N. Manfredi Pierino; 71 Art. Carmignani Ettore; 72 Cap. Cancian Angelo; 73 C.N.S. Brunini Guido; 74 C.N. Leon Romano; 75 C.N. Cocetta Giovan Battista; 76 C.N. Giroldo Giuseppe; 77 Ignoto; 78 Sold. Stradaioli Ciro; 79 C.N. Gibertini Umberto; 80 C.N.S. Ferigutti Olivo; 81 C.N. Garofolo Umberto; 82 C.N. Piccinini Dante; 83 C.N. Missiroli Guido; 84 V.C.S. Bonini Ildebrando; 85 C.N. Fontanini Virgilio; 86 Sold. Fazio Francesco; 87 V.C.S. Gonzaga Amaldino; 88 C.N. Buttignol Attilio; 89 C.N. Urizzi Francesco; 90 C.N. Codeluppi Faliero; 91 C.N.S. Bagnoli Vincenzo; 92 C.N. Pisa Umberto; 93 C.N. Cicognani Sante; 94 Cpl Aiello Francesco; 95 C.N. Corradini Glicerio; 96 C.N. D’Antoni Mario; 97 C.N. Carletti Amelio; 98 C.N.S. Benatti Silvio; 99 V.C.S. Boldarino Elio; 100 C.N. Castagnoli Giuseppe; 101 C.N. Brini Romeo; 102 Sold. Mezghez Rodolfo; 103 Serg. Zanette Riccardo; 104 Sold. Pin Angelo; 105 C.N. Cisilino Sirio; 106 C.N. Manghi Giuseppe; 107 C.N. Cogoi Arcangelo; 108 V.C.S. Mauro Vittorio; 109 C.N. Venier Quinto; 110 C.S. Tagliavini Otello; 111 C.N. Salati Manfredo; 112 V.C.S. Zanoni Adriano; 113 C.Man. Zago Mario; 114 C.N. Bartoli Diego; 115 C.N. Pasin Domenico; 116 Sold. Mulloni Luigi; 117 V.C.S. Bertolino Domenico; 118 C.N.S. Paniate Remo; 119 C.S. Pinardi Enrico; 120 C.N. Cavazzini Augusto; 121 C.N. Corradini Dermino; 122 C.N. Schipani Domenico; 123 C.N. Ferrarese Guido; 124 C.N. Paolucci Mario; 125 C.N. Ombre Carlo; 126 V.C.S. Piccioni Giuseppe; 127 C.N. Torna Eugenio; 128 C.N. Costa Cristiano; 129 C.N. Torsa Santo.
Osservazioni sull’Elenco Caduti.
A questi bisogna aggiungere i 16 Caduti prima di Gorlovka, e cioè:
C.N. Scarpin Ugo; C.N. Casali Igino; V.C.S. Sbaiz Francesco; C.N. Fornaciari Mario; C.N. Folloni Gino; Aut. Marin Dino; C.N. Zuttion Severino; C.N. Peresson Antonio; C.N. Bariviera Luigi; C.N. De Ponte Luigi; C.N. Pirusel Edoardo; V.C.S. De Roia Leonardo; C.N. Colautti Giovanni; C.N. Passon Gino; C.N. Pisaroni Sincero; C.N. Parigi Carlo.
E per avere il quadro completo di tutti i nostri Caduti, bisognerebbe aggiungere ancora l’elenco dei circa 70 Dispersi del Natale 1941 e quello dei Caduti e Dispersi nell’agosto-dicembre 1942.
